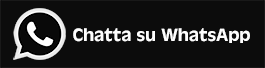Per un secolo di musica che deve ancora (ri)vivere
Passata la soglia del millennio, ci si domanda giustamente cosa «resta del secolo» [Il Giornale della Musica], ma il fatto è che la produzione musicale degli ultimi cento anni è rimasta in larga parte inascoltata, incompresa e bistrattata, persino da molti famosi strumentisti, direttori d’orchestra, nonché relegata a una disamina critica disorganizzata, episodica, incapace di evidenziare "paesaggi" della produzione musicale non imbrigliati né da retaggi nazionalistici, basti confrontare un libro anglosassone con uno francese sulla musica del Novecento, il 60% dei nomi sono diversi, né da differenziazioni di "genere" pregiudiziali (contemporanea, minimalismo, new age, jazz d’avanguardia, art rock, ecc.). Chi si è inoltrato nei territori del Novecento ha finito o per limitarsi ai grandi mostri sacri della prima metà del secolo, o si è limitato a un dizionario informativo di nomi e di composizioni mascherato da "storia" organica di un periodo, o infine si è allegramente compiaciuto di mischiare le carte, di equiparare i percorsi di Philip Glass con quelli di Stockhausen, di sostenere che Prince non è in fondo da buttare via, oppure che la musica "estone" o new age, o ancora il neoromanticismo, siano le vere note positive dopo tanta avanguardia "inascoltabile". Ora l’avanguardia, anche quella anni cinquanta (davvero, finiamola con la svalutazione di quel periodo), è ascoltabilissima, e se il nostro orecchio ancora annaspa è semplicemente perché ogni giorno è educato malissimo. Che manchino grandi compositori, nel secondo Novecento, non paragonabili a quelli del passato, è una leggenda metropolitana rassicurante, che consente di risparmiarsi un confronto con il proprio tempo: pensiamo a Nono, Boulez, Stockhausen, Ligeti, Maderna, Kurtág, Messiaen, Feldman, Rihm, Scelsi, Wolpe, Xenakis, Berio, Carter, Lutoslawski, Zimmermann, Gubaidolina, Lachenmann, per limitarsi a qualche nome. Il fatto è che mancano categorie estetiche e riflessioni sul compito dell’arte, che prevale un atteggiamento presuntuoso, narcisista, di chi deve soccorrere con l’autorità dello scrivere il proprio gusto, costruito nel tempo tenendosi ben lontano da qualsiasi dialogo con le altre arti e tanto più da qualsiasi "sublimazione": già, un termine per dire crescere, ossia sostituire un appagamento scontato con la ricerca di un mettersi in cammino, arte quest’ultima sempre più sconosciuta, in un tempo in cui l’alienazione è divenuta ormai, vox populi, peculiarità di colui che pensa, che si intristisce nei ragionamenti, che si "scollega" con il variopinto e scintillante mondo dei "promo alla vita" quali sono le mode e i messaggi pubblicitari che le sostengono. Bene fa Bortolotto a sostenere senza mezzi termini che si è trattata di una cultura di élite, quella del Novecento, ed infatti non si vede perché improvvisamente la massa (per usare una terminologia francofortese) impazzisca per i quartetti di Beethoven [GdM, p. 1], o aggiungiamo noi per Joyce, per Klee, per Scarpa, per Tarkovskij. Più difficile è comprendere la ragione della rilassatezza intellettuale di fine Novecento, dove il criticismo è finito sotto i piedi e ci si sente alla moda (al passo coi tempi) solo dimostrando uno spirito casual, come quello di Bruno Canino, capace di accostare nella sua personalissima hit parade Le marteau sans maître o Mantra con Yesterday o Satisfaction: perfetto! Credo che molti nostri lettori, ascoltino la contemporanea sapendo abbandonarsi anche alle canzonette, ma non saprebbero mettere sullo stesso piano cose così disparate, come invece sanno fare benissimo le menti chic di qualche "professionista" della musica. In questo senso, inutile entrare nel merito delle opere favorite di Franco Fabbri, ovviamente motivate da un palpitante sottobosco sociologico, rispetto alle sradicate e astratte opere colte e borghesi: peccato allora che Henry Cow e Art Bears (la punta più alta dell’art rock, se si vuole insieme a Zappa) siano mischiati a Prince, Mina e Celentano. Ma il peggio si registra con uno dei nostri italianissimi neoromantici, Lorenzo Ferrero, il quale si dichiara sicuro che ai «funamboli dell’intelletto» si preferiranno e sopravviveranno nella memoria dei tempi Prokofiev, Poulenc e Bernstein e che il resto (i compositori citati da noi sopra) non sono che il triste documento in musica di un «secolo che ha seminato più morti per ideologia che buone idee per vivere meglio» [GdM, p. iv]. Che dire? Che Ferrero è la testimonianza di quanto si possa essere miopi anche in campo sonoro, che i gusti sono sempre capricciosi e quindi tutti legittimi, o che la mamma dei cretini è sempre incinta? Il Giornale della Musica non poteva risparmiarsi di invitare anche Marco Tutino al gioco delle cose da salvare del ‘900 e come il suo "compagno" Ferrero, ecco allora che, se riconosce almeno la presenza dell’avanguardia (si è accorto che c’è), non meno ritiene che Beatles, Sting, Jarrett e Lloyd Webber siano capisaldi del secolo tutto. Si continua con l’accozzaglia libertaria e libertina dell’elenco smisurato di cose da salvare di Giordano Montecchi, che dopo ampia riflessione ha semplicemente messo in ordine alfabetico gli artisti di cui possiede un disco che ama a casa sua (e quasi se ne vanta: molto chic davvero). Possiamo pacificarci con le parole profetiche di Marcello Piras, che decretando il quartetto d’archi un oggetto da museo già a partire dall’opera 28 di Webern (deve avergli fatto proprio male), vede in Prince e in Gershwin, e in Zappa (speriamo in quello di Phase Civilization III e non in quello di Joe’s Garage, Bertoncelli ci perdoni) il «futuro della musica» (in corsivo nel testo, segno che percepiva l’importanza di quanto stava sostenendo). Se qualcuno aveva dei dubbi sulla cultura musicale di Nicola Piovani (autore di colonne sonore, tutte sapientemente "carine", ma non per questo non funzionali), eccolo servito: dobbiamo a Duke Ellington, Weill, Piazzolla, Rota, Lennon e Lloyd Webber, se «la musica del ventesimo secolo non si è sepolta a Darmstadt come qualche filosofo desiderava». Non c’è dubbio che sarebbero rimasti sepolti molti lauti "budget" di tanti compositori "avvertiti". Per fortuna nel dossier del Giornale della Musica compaiono anche delle disamine personali più interessanti, dove si sciorinano i nomi fondamentali del secolo: ecco Chailly aggiungere ai nomi canonici (scuola di Vienna, Mahler, ecc.) compositori ritenuti decisivi come Zemlinsky, Varèse, Ives. Michele Porzio compie lo sforzo critico più serio e individua tre filoni principali nella musica del Novecento: una «"compresenza" sincronica e simultaneistica delle opzioni stilistiche» (da Strawinsky a Busoni, Schnittke, Pärt, Zimmermann, Rihm; una ricerca sul suono (da Varèse a Cage, Scelsi, Feldman, Nono e le miglior cose, non commerciali, del minimalismo); una terza via spirituale e antitecnologica (ancora Cage e Pärt fino al giapponese Somei Satoh e al cinese Tan Dun). Non molto, non condivisibile, ma almeno una posizione seria. Insomma, tutto qui, il dossier del Giornale della Musica, perfetto esempio del tenore del dibattito sulla musica del Novecento. Ma se si prendono in considerazione campi quali il cinema o la letteratura, non credo che il panorama intellettuale che ne esca sia migliore. In un periodo di decadenza, soprattutto della classe intellettuale - di artisti in Italia continuano ad essercene, per fortuna, molti e di livello internazionale -, ci si ritrova a motivare la scelta di mettere in circolazione la propria "voce", fondando una rivista come Orfeo nella Rete, proprio per segnalare almeno che esistono delle "differenze", che malgrado tutto vi sono persone che fanno altre ricerche e danno un diverso senso all’arte del presente. Il nostro percorrere spesso il Novecento musicale si rimotiva ogni volta che leggiamo stralci di dibattito come quello sopra citato, ogni volta che ci accorgiamo che mancano opere critiche che sappiano leggere esteticamente ma in modo "organico" il panorama frastagliato della scena musicale contemporanea, ogni volta che percepiamo in opere certo poco ascoltate la trama di una storia "altra", la testimonianza di diversi cammini, la presenza di comunità aperte, trasversali, transnazionali. Quanto alla musica del Novecento essa rimane in larga parte un secolo di musica tutto ancora da (ri)vivere, un patrimonio di grandissima importanza che credo lascerà emergere come la musica sia stata in questo secolo, non solo "salubremente" l’arte meno incline alle derive concettualistiche, ma anche uno dei pilastri e dei punti di riferimento più solidi della nostra cultura. Nell’alveo del postmoderno è giusto che si intonino, modestamente e perifericamente, dei controcanti; giusto forse per rilevare che con la scusa di legittimare le culture pop si è finito subdolamente per trasformare quella che Bortolotto chiama una cultura di élite in una emarginata sub-cultura, o peggio in una colonia del senso comune.
"Quel che resta del secolo" ne Il giornale della musica, anno XVI, n. 156, gennaio 2000.
Pier Luigi Basso (da www.orfeonellarete.it)