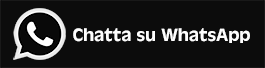L’Oriente di Stravinskij
Le chant du rossignol non appartiene probabilmente al ristretto novero di quei capolavori che hanno reso Stravinskij "il" compositore moderno per eccellenza, pure non è un lavoro "minore", tant'è vero che le sue esecuzioni non sono affatto rare. Tra l'altro, oltre agli indubbi meriti musicali, la materia stessa da cui nasce e che sapientemente viene distillata in un elegante poema sinfonico (Le chant è la trasposizione sinfonica dell'opera Le rossignol, alleggerita – per motivi di discontinuità stilistica – dell'intero primo atto) offre il destro a esercizi interpretativi non estranei all'attualità. Due di essi hanno a che fare con una-certa-idea-di Oriente (e il suo rapporto con l'Occidente), e l'antitesi naturale-artificiale da cui discende, come inevitabile corollario, quel sospetto con cui ciò che è "artificiale" viene tenuto in considerazione rispetto al "naturale" (Stravinskij scriveva Le chant in piena era di trionfo della Macchina, e dunque – come si suol dire – in anni insospettabili). Problemi di natura ideologica, si dirà, ma che hanno qui un loro singolare corrispettivo estetico, sonoramente identificato. Andrebbe prima detto però che Le rossignol, conte lyrique, fiaba operistica composta tra il 1908 e il 1914, fu concepito in un'epoca in cui ancora Stravinskij gravitava attorno a Rimskij-Korsakov e si collega a uno dei generi principali dell'opera russa, quello praticato soprattutto da Glinka e Rimskij-Korsakov, ovvero la fiaba (in questo caso quella assai nota di Andersen). Nel corso del lungo periodo della gestazione (praticamente, nel 1909, dopo aver composto il primo atto, smise del tutto di lavorarci per riprenderla solo nel 1914) accade praticamente "tutto": grazie all'incontro con Djagilev e con i Ballets Russes Stravinskij dà vita a quel miracoloso "trittico" (L'oiseau de feu, 1910; Petruska, 1911; Sacre du Printemps, 1913) con il quale raggiunse la sua piena maturità artistica guadagnando nel contempo fama internazionale. Orientalismo, e poi esotismo e primitivismo: questo era quello che faceva impazzire Parigi e l'Europa in quegli anni pur tragici, e la Russia e tutto ciò che era russo o da lì proveniva (come gli stessi Djagilev e Stravinskij) veniva messo nel colorato mucchio. Le chant si collocava, buon ultimo, su una lunga linea che attraversa buona parte della storia della musica russa (a partire perlomeno dall'Uccello di fuoco di Catterino Cavos) e che corrisponde a ciò che anche in area slava viene denominato orientalistika o tema vostoka – il tema orientale. E anche nella cultura russa (non esente da nessi con la politica imperial-coloniale che proseguirà fino alla giustamente sfortunata occupazione dell'Afghanistan) l'Oriente è una geografia immaginaria, una finzione storica, una fruttuosa metafora che è quintessenza dell'"alterità", su cui – in negativo o per contrasto – si costruisce la propria "identità". Stravinskij affronta il tema dell'orientalismo senza porsi velleità di verosimiglianza: la sua è una deliberata e ironica falsificazione, che "flirta" con il kitsch più vieto (ad esempio quello con cui viene rappresentata la corte dell'Imperatore), rovistando divertito nel bric-à-brac dell'esotismo in musica (dove figurano, tra gli altri, il Rimskij-Korsakov di Shéhérazade o il Balakirev di Thamar). Ne Le chant si rinvengono ancora consistenti residui (sospesi in quella sorta di "equilibrio funambolico" che già contraddistingue la scrittura stravinskiana) di quella "energetica", quella "violenza a impossessarsi della musica" o "giovinezza nell'esproprio" (Boulez), di quell'aggressività ritmica che aveva potentemente contraddistinto Le Sacre e ancora prima L'oiseau. Ma tutto risulta più diafano, come distante, a causa anche degli elementi così distintamente stereotipi, coi quali Stravinskij gioca con suprema divertita leggerezza, con il pretesto della bizzarria e dell'improbabilità delle situazioni originariamente rappresentate. Così ascoltandolo oggi pare che nel Chant Stravinskij si sia quasi divertito a mixare, a sovrapporre loop di ostinati ritmici modaleggianti (direttamente imparentati con quelli de Le Sacre o con la Danza infernale di Katscheï nell'Oiseau) con paccottiglia esotica di varia provenienza, bizzarre e improbabili forme di chinoiserie musicale che si muovono su e giù pentatonicamente. Ecco allora le tintinnabulazioni metalliche di un usignolo meccanico made in Japan – lo stesso Stravinskij lo definiva "il ronzante mostro" – con quel suo "tormentone" nippo-pentatonico (ma contaminato con varie impurità cromatiche), contrapposte alle fioriture melismatiche e vagamente atonali dell'usignolo più propriamente (e politicamente corretto, o New Age?) BIOlogico. Non c'è che dire: il lavoro ha una sua attualità (come sempre accade in Stravinskij): la sfida in musica tra "artificiale/replicante" (presago di clonazioni ante litteram, pre-transgenico o più volgarmente: taroccato) e "biologico/naturale" ha un suo appeal irresistibile che ci trasporta in un'atmosfera di "realismo magico". Eppure ciò che dovrebbe essere la quintessenza della naturalezza, ovvero il canto dell'usignolo, risuona poi inevitabilmente ancor più puro artificio in virtù del suo carattere iper-virtuosistico (affidato a una voce di soprano di coloratura nell'opera, e al flauto o al violino nel poema sinfonico). Ma è con il Canto del pescatore (una sorta di figura "rousseauiana" smarritasi in una Cina immaginaria) che dopo i meccanismi sonori «molto curiosi e attraenti» riemerge quella rassegnazione, «quella "orizzontalità" che della musica russa fa un camminar perpetuo e senza meta» (Savinio: un altro che aveva capito molte cose…).
Franco Masotti (da www.sistemamusica.it)