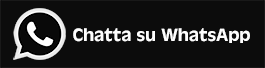Il suono etico
Ciò che è essenziale, è la filosofia della musica Nera. (Amiri Baraka)
"Mentre Talete guardava in alto per scrutare le stelle, cadde in un pozzo. Allora una servetta di Tracia, gentile e graziosa, rise, dicendo che egli si dava tanto da fare per conoscere le cose del cielo ma gli restavano ignote quelle che aveva vicino, davanti ai suoi piedi". Questo passo del Teeteto di Platone è stato più volte ripreso nel corso del tempo e variamente interpretato, ma sempre al fine di sottolineare l'incolmabile distanza fra l'atteggiamento contemplativo del filosofo e il buon senso della gente comune. Esso è infine diventato oggetto di uno studio di Hans Blumenberg, che ripercorre la vicenda ermeneutica di un aneddoto di volta in volta usato in chiave metafisica, per sottolineare la grettezza di quanti non capiscono l'importanza della speculazione filosofica, o antimetafisica, per irridere chi inciampa negli ostacoli della vita perché assorto nella contemplazione di una realtà considerata superiore.
Della servetta di Tracia si è occupata anche Adriana Cavarero, in un saggio significativamente intitolato Nonostante Platone e volto a discutere l'ordine simbolico occidentale centrato sulle pretese universalistiche della soggettività maschile. Ma se quel che interessa principalmente l'autrice, rappresentante del cosiddetto "pensiero della differenza", è sottrarre a un autorevole contesto filosofico alcune figure (nel libro, oltre alla servetta compaiono Penelope, Demetra e Diotima) utili a fondare un'identità femminile, e un relativo ordine simbolico, dotati di autonoma significazione, particolarmente interessante risulta il percorso argomentativo.
Tutto inizia dunque con Talete, che imprime alla filosofia la sua 'corretta' direzione affermando che il senso del mondo va ricercato fuori dal mondo, e prestando la sua attenzione a qualcosa che sta più in alto della realtà quotidiana, cioè alla lontana fissità delle stelle. Insieme a un fondamentale dualismo - che tanto influirà sul corso della filosofia -, s'inaugura così la priorità delle "cose che sono" nella loro immutabilità rispetto a quelle "che ci appaiono" nella loro caducità: vere e reali sono le prime, e ad esse il filosofo deve rivolgersi distraendo la sua attenzione dal mondo delle apparenze. Capovolgendo ciò che è percepito dal senso comune, viene in questo modo sancita la derealizzazione del mondo della vita, e ridotta a mera apparenza la concretezza del suo manifestarsi. La successiva radicalizzazione operata da Parmenide introduce una netta separazione fra essere, inteso come regno della pienezza, e non essere in quanto regno di ciò che non consistendo in niente, non può essere pensato. All'essere nella sua fissità (l'essere delle "cose che sono") attiene l'universo del pensiero, luogo privilegiato della verità e dunque dell'ordine, al non essere l'eterogenea multiformità del reale in quanto esterna all'essere. Per questa via vengono drasticamente separati il piano del pensiero e quello dell'esperienza sensibile, l'eterno (dimora del filosofo) dal caduco (regno del fenomenico), ovvero l'assoluto dell'essere dalla relatività di quel divenire che il pensiero ha abbandonato per assurgere alla sua incontaminata purezza. Affermando la verità del pensiero puro e smaterializzato, Parmenide deduce la falsità ovvero l'irrealtà di tutto ciò che lo contrasta; cosicché l'astrazione, autoconsiderandosi la sola realtà, denuncia come apparente e illusorio ciò che le è estraneo.
Tale dicotomia viene ereditata dalla tradizione filosofica successiva attraverso la mediazione di Platone, il quale tuttavia recupera il molteplice e rende pensabile l'eterogeneo dopo averli subordinati al regno delle idee, solo oggetto della conoscenza. Platone insomma, preoccupato delle conseguenze del radicalismo parmenideo che nientifica il reale, e interessato a rendere pensabile la molteplicità dei fenomeni, restituisce cittadinanza filosofica al non essere assumendolo nella categoria del diverso. Questa operazione, che rende nominabili le qualità del mondo, si inserisce tuttavia in un quadro teorico prestabilito e assai rigido, che sancendo la distinzione fra vera e falsa conoscenza, fra episteme e doxa, assume la concretezza della vita come inutile zavorra al procedere del lavoro filosofico inteso come discorso razionale o logos. Sono così predisposte le basi di ogni successiva metafisica, ossia di ogni speculazione intesa a gerarchizzare il conoscibile separando ciò che riguarda i corpi e la materia da quanto invece li supera e oltrepassa: meta ta physika.
Dopo di che, sortito dalla mente dei padri greci sotto queste spoglie, il pensiero occidentale ha continuato a viaggiare nei secoli (e nel linguaggio) rendendosi disponibile a infinite contaminazioni, ma sempre continuando ad occuparsi di quegli oggetti incorporei che Nietzsche indicava come "gli ultimi fumi della svaporante realtà".
Ma cosa nasconde la disperata negazione del mondo sottesa alla nascita della filosofia? L'orribile, angoscioso richiamo della morte, risponde Cavarero, destinazione ultima di ogni divenire. Cosicché il mutamento e la trasformazione, invece di rappresentare la positività di ogni esperienza concreta, si svalutano nel lugubre passaggio da un niente prenatale a un niente postnatale, da un prima a un dopo misurati sul trascorrere di una vita vissuta come malattia infallibilmente mortale, nella convinzione che solo ciò che dura sfugga alla legge del divenire, al passaggio dal non esserci ancora al non esserci più.
Pur sfumato dalla mediazione platonica, il dualismo parmenideo e la correlativa, angosciosa centralità della morte che induce a eternizzare gli oggetti del pensiero - cioè l''oggetto' della filosofia - resta decisivo per la tradizione occidentale, secondo la quale l'essere dell'uomo coincide con il suo pensare le "cose che sono", anche se tale attività lo porta in fondo al pozzo.
Ciò che muove il riso della servetta di Tracia sarebbe dunque l'evidente (al suo sguardo di donna e di schiava) "menzogna" della filosofia, il riconoscimento della sostanza illusoria di ogni atto teoretico teso a svilire la concreta individualità delle singole esistenze: ma donna e schiava, la servetta resterebbe doppiamente estranea a tale ordine simbolico menzognero, nel quale "il verisimile, generatosi dalla derealizzazione del vero, penetra in ogni luogo, attecchisce, cresce ed occulta. Cosicché il mondo della vita non scompare, ma rimane nascosto" (Cavarero).
Il risultato di un pensiero che si regge celando la verità dei fatti, siano essi la concretezza di un pozzo o l'ineliminabile presenza della morte, sarebbe dunque la negazione della vita. Da questa origine deriverebbe la natura duale e separativa del logos: che resta tale nonostante le metamorfosi subite nel corso dei secoli, che ritiene di poter sottomettere ogni cosa al controllo dell'intelletto, che si appropria indebitamente dell'idea di universalità, che esclude ciò che non può integrare nel proprio orizzonte e considera senza senso le domande che non hanno risposta Questa la cupa eredità della filosofia, questo il lascito di Platone che Giorgio Colli, in modi diversi ma altrettanto suggestivi, aveva già collocato non al culmine dell'eccellenza greca ma al suo punto di svolta verso il basso.
Ora, se è vero che tracce del dualismo metafisico-platonico e di quanto da esso procede sono rinvenibili in tutta la storia del pensiero occidentale, esse non hanno mancato di condizionare la riflessione nei vari ambiti in cui si è articolato. Le ritroviamo infatti alla base di ogni canonizzazione, di ogni esigenza normativa, di ogni tassonomia, infine di ogni ambito discorsivo costruito attorno a coppie antinomiche quali bello/brutto, autentico/artificiale, ortodosso/eterodosso. Esse non toccano solo la sfera delle cose dell'arte, ma relativamente a quella sono presenti in ogni idea che pensi l'opera come ideale separato dalla sua concreta realizzazione, che ipotizzi una forza creatrice slegata dall'opacità della materia, che subordini l'esperienza al sovrasensibile e ponga la trascendenza dell'assoluto. E in verità non è facile comprendere l'insistenza con cui anche in pieno Novecento si è perseguita l'idea di un'arte senza oggetto (dai suprematisti agli astrattisti, da Duchamp fino a Carlo Belli), se non come persistenza di una concezione metafisica dell'arte, che sacralizza (anche quando dissacra) l'idea a scapito della sua realizzazione. Se poi consideriamo la stretta sorveglianza ideologica esercitata in occidente sulla musica, a causa della sua natura sfuggente e imprendibile, non stupirà ritrovare il medesimo orizzonte concettuale condiviso dai musicisti. Certo, a ben vedere il dualismo parrebbe connaturato all'essenza stessa della musica di tradizione colta, se è vero che essa si sdoppia fra una scrittura che la fissa una volta per sempre e le molteplici interpretazioni che la fanno esistere nel tempo. Col risultato che non c'è possibilità di reale integrazione fra le due parti, ma solo quella di un ipotetico avvicendamento o quella, ben più concreta, di una sostanziale supremazia della partitura. Come peraltro conferma tutta una tradizione che pensa l'atto del comporre come sviluppo di un'idea data (Boulez), o ritiene dovere dell'interprete sperimentare e far sperimentare quella verità che l'opera possiede in se stessa (Leibowitz): coerentemente con l'estetica hegeliana che considera la forma solo in quanto purificata, liberata cioè da quanto la tiene prigioniera della sua miserabile finitudine. Da un lato dunque avremmo l'opera, immutabile e consegnata al suo in-sé: l'impalpabile scrittura; dall'altro l'interprete come oggetto mediatore, semplice elemento di collegamento fra l'essenza dell'idea musicale e il divenire dell'opera. Quanto al corpo - quello dell'interprete come quello dell'ascoltatore - esso è concepito come ombra portata, traccia della pesantezza di un reale assolutamente ingombrante ma idealmente trasceso: dal primo mediante la tecnica, appresa con ferrea disciplina, e dal secondo con l'ineffabile esperienza dell'ascolto. Chiuso il cerchio, la moderna idea dell'arte si ricongiunge all'originario dualismo metafisico. E ciò, nonostante il maturare di un diffuso disincanto dovuto alla crisi del modello classico di razionalità, alla constatata difficoltà di dire l'indicibile, alla radicale dissoluzione del senso. La ferita apertasi con la modernità, ovvero quell'incrinatura dell'anima segnalata da Kandinskij quale traccia del passaggio da un fondamento illusorio all'incertezza della condizione attuale, indica nella costruzione di una nuova e "diversa metafisica dell'arte moderna" (Lisciani- Petrini) l'imprescindibile orizzonte destinale dell'occidente.
Potrà forse sorprendere il ritrovare elementi di questa concezione nell'opera di un filosofo come Theodor W. Adorno, che si volle nemico di ogni metafisica. E tuttavia dalla sua Teoria estetica apprendiamo come egli consideri le partiture più importanti delle esecuzioni, poiché esse, lungi dal ridursi a semplici indicazioni in vista delle esecuzioni, attingono all'essenza della cosa in sé: "Le esecuzioni di un'opera musicale sono meno interessanti della partitura, la quale a sua volta è meno interessante dell'idea del compositore". Con il che rientriamo a pieno titolo in un ambito concettuale platonico e dialettico.
Ma il caso del francofortese si presenta assolutamente emblematico per una lettura filosofica del jazz, poiché il suo giudizio negativo - espresso nel noto Moda senza tempo - necessita di un ripensamento. Vero è che, provenendo da un tale monumento della musicologia filosofica contemporanea, da sempre costituisce una palestra imprescindibile per l'apprendistato dei critici, e tuttavia le varie e pur motivate obiezioni finora rivoltegli non hanno a mio parere restituito un quadro convincente delle ragioni del filosofo, della sua persistente ostilità verso la musica afroamericana.
Di un tale compito si è incaricato Christian Béthune in un saggio intitolato Adorno et le jazz. Ciò che prima di tutto si apprende da questa lettura è che l'attenzione di Adorno non fu affatto sporadica e occasionale, poiché le ricerche attestano l'esistenza di un certo numero di suoi testi dedicati all'argomento e distribuiti nel tempo. La cosa riveste un notevole interesse storico e teorico, accresciuto dal confronto con altri significativi accenni al jazz, alla musica popolare e in generale al problema della ricezione rinvenibili nel corpus delle opere. Comune a tutti gli scritti, nonostante le varianti di dettaglio, resta l'atteggiamento fondamentalmente negativo e svalorizzante.
Secondo Béthune, tale persistente svalutazione sarebbe dovuta a una sorta di malinteso, o per meglio dire a un'impossibilità concettuale: ripetutamente sollecitato dall'ascolto di questa musica, il filosofo non perverrebbe mai a comprenderla a causa di una drammatica sordità, insieme sensoriale e intellettuale, indissolubilmente legata alla sua concezione estetica. L'ascolto di Adorno sarebbe insomma pregiudicato da una sordità filosofica. Quando egli ascolta il jazz, la ricezione risulta disturbata da presupposti teorici che annullano la reale portata della sua esperienza empirica, privandola di una prospettiva filosofica. E semmai gli accada di cogliere qualche aspetto delle più intime ragioni di questa musica, non riesce a percepirne i riverberi estetici. Legato alla forma di un logos dialetticamente ordinato e razionale anche in ambito musicale - lo stesso che in occidente ha separato, opponendole, oralità e scrittura - non si avvede che il jazz parla una lingua a tale logos irriducibile, e continua testardamente ad assegnarlo a una forma di linguaggio scritto, ovvero a quella che Jack Goody chiamerebbe la "ragione grafica". Dopo di che, nell'impossibilità di assumerlo nelle categorie della dialettica pronuncia la condanna, espungendolo dalla sfera dell'arte e da quella dell'esistenza stessa. Le caratteristiche di quella musica (ruolo della fisicità, gusto della performance, disponibilità all'improvvisazione) gli sembrano assolutamente lontane dall'essere (delle "cose che sono") e pure manifestazioni dell'apparire (dunque alla "moda" in quanto effimero), anche perché pericolosamente ludiche e inclini alla clownerie, dunque inaccettabili per chi aspira a un ideale ascetico dell'arte: "Il borghese desidera che l'arte sia voluttuosa e la vita ascetica; il contrario sarebbe meglio".
Anche a causa dell'equivoco sotteso alla considerazione del jazz come arte ludica e superficiale, Adorno rappresenta al meglio l'impossibilità del pensiero occidentale di penetrare fenomeni che si sottraggono alle sue categorie. Come potrebbe infatti una filosofia basata sulla concezione lineare del tempo, sul superamento dialettico degli opposti, sulla rigida distinzione fra colto e popolare, sulla supremazia della scrittura, accettare una forma espressiva che tutto mescola e reinterpreta secondo le proprie ragioni? Basti considerare il problema dell'approccio al tempo, storico e musicale. Sappiamo come la dinamica ripetizione-variazione sia tipica del jazz, musica fondata su una ratio intessuta di continui ritorni e riprese. La forma ricorrente tema - variazioni - tema organizzerebbe, secondo Béthune, una durata circolare dell'esecuzione musicale in opposizione con il modello cronologico con cui abitualmente apprendiamo l'ordine del tempo. Il rifiuto della concezione dialettica e lineare che regola la nostra idea di sviluppo temporale produrrebbe così un'originale risposta poetica alla questione dell'irreversibilità del tempo, il tentativo di una sua radicale messa a morte. Il 'tempo del jazz', insomma, rigettando l'idea di un divenire dialetticamente teso alla realizzazione di un in-sé predeterminato, si sottrarrebbe a ogni teleologia, a ogni concezione finalistica dell'opera, ricorrendo a tal fine anche all'uso spregiudicato di sostanze che alterano la percezione temporale, se è vero che "la questione del Tempo, l'alterità del Tempo della droga [...] costituisce un nesso fondamentale per comprendere la relazione che intercorre tra esperienza estetica e tossicomania" (Restante-Tartarini).
Da tale approccio, ricco di implicazioni etiche oltre che estetiche, discende la difficoltà stessa di concepire una 'storia' del jazz intesa nel senso di un faticoso ma definitivo superamento di certe condizioni originarie. E siccome senza storia non può esserci filologia, varrebbe la pena ripensare il senso dell'interpretazione musicale, dalle riletture più o meno fedeli al fenomeno dei revival, ovvero a come diversamente si organizzano nella musica colta e nella tradizione jazzistica le riprese del passato. Se nella prima tendono a misurare la distanza fra un prima e un dopo, fra ciò che è stato e ciò che è, marcando le tappe di un avanzamento scandito con rigore quasi militare (di cui è spia l'origine del termine 'avanguardia') e fiducioso nelle possibilità conoscitive individuali, nella seconda indicano piuttosto i modi di un'ininterrotta ricerca di identità, fondata certo sul passato ma proiettata nel futuro e vissuta nel presente all'interno di una dimensione comunitaria. Nel lavoro del jazzman, infatti, non è mai questione di ripristino archeologico dell'esattezza dei ricordi, di fiducia nell'oggettività della memoria, quanto piuttosto di assunzione critica della propria storia: è questione di riordinare le contingenze passate dando loro il senso delle necessità future, poiché la ripetizione è una forma di storicizzazione. Che questo avvenga prioritariamente nella dimensione dell'oralità costituisce una delle ragioni per cui la koiné jazzistica non vive quell'"angoscia dell'influenza" che a parere di Harold Bloom caratterizza il lavoro dell'artista occidentale, la sua perenne ricerca d'originalità. Come ha scritto John P. Murphy, la scelta dell'improvvisazione e la valorizzazione del momento performativo evidenziano semmai una profonda "gioia" dell'influenza, ovvero la sua esplicita celebrazione. Non a caso anche gli artisti più radicali e innovatori hanno sempre ribadito il loro legame con la tradizione: da John Coltrane ad Archie Shepp, da Ornette Coleman a Cecil Taylor. Spiega a questo proposito Max Roach: "Io vedo il jazz come un grande fiume sempre in movimento, dunque ogni generazione può apportare qualcosa di nuovo. Tuttavia ogni generazione è in un certo senso obbligata a guardarsi alle spalle: quel che conta è la continuità col passato piuttosto che la rottura. Il jazz è una musica democratica, che tiene conto degli apporti individuali per arrivare a una creazione collettiva". Non so se Roach legga Eraclito, e tuttavia ciò che appare significativo nella scelta della metafora fluviale è propriamente il legame istituito fra essere e divenire: l'acqua del fiume non è mai la stessa, essa scorre, e giustamente ci si è domandati se sia possibile bagnarsi due volte nell'acqua dello stesso fiume. Ma è proprio l'incessante movimento del fluire a collegare la sorgente al mare, cioè l'origine al suo futuro. Per questo il fiume è divenuto fin dall'antichità figura dell'identità e metafora della vita, dal momento che, come assicurano i filosofi, la vita può essere compresa solo guardando indietro ma va vissuta guardando avanti.
Per Roach il movimento è esattamente ciò che lega, non ciò che separa In termini filosofici potremmo dire che per lui si tratta di cercare il senso ultimo dell'essere non nella sostanza, nell'ousia, ma nella kinesis, cioè nel movimento, nel prodursi della cosa dalla potenza all'atto. Poiché tutto si organizza e si significa non nel gesto isolato dell'avanguardista, ma all'interno di un dimensione comunitaria ove si intrecciano indissolubilmente ethos e àisthesis, comportamento morale ed esperienza del bello. Per questo e altro ancora, come sostiene Béthune, il jazz pone in essere una radicale critica delle categorie dell'estetica, in quanto forma d'espressione che mette in scacco le dicotomie a partire dalle quali essa organizza il discorso sull'arte.
Ma infine, cos'hanno in comune la servetta di Tracia e Charlie Parker?
Prima di tutto essi condividono una posizione eccentrica rispetto all'ordine simbolico dominante, l'ordine maschile e logocentrico in cui la soggettività, reperendosi nello spazio topologico (e ideologico) del patriarcato, sa concepirsi solo come fondamento ontologico, non come mosaico di pratiche e intreccio di nodi esperienziali. Un ordine rigido ed escludente che aderisce alla tradizione di un pensiero profondamente radicato nell'idea dell'ordinato e del classificabile, del gerarchico e dunque, conseguentemente, del centrato. La semantica del centro costituisce infatti una forma archetipale del sapere, che si accampa ovunque: nelle dottrine cosmologiche e nella teologia, nella filosofia, nella storia e nella scienza. Di conseguenza la geometria del cerchio - la più intransigente fra le figure dell'ordine -, dopo essere stata orizzonte speculativo dell'antichità e traccia dell'immanenza divina nel medioevo cristiano è giunta a noi mantenendo pressoché intatta la sua autorità. Ragione per cui la circolarità - come scrive Poulet -, installandosi come orizzonte coercitivo, come schema formale in grado di assoggettare le forme del reale, rafforza la centralità del soggetto determinandone la visione. Fidando nell'obiettività prospettica che tale posizione sembra garantire al soggetto della conoscenza, l'occidente - ma sarebbe meglio dire l'occidente bianco e maschile - ha elaborato la propria monolitica Weltanschauung, da cui restano esclusi quanti occupano una posizione periferica o marginale: le donne e le minoranze.
Il 'peccato originale' del jazz consiste allora esattamente nella sua eccentricità, contro la quale si scaglia Adorno assumendo una posizione al contempo logocentrica ed eurocentrica, nel vitalismo che il filosofo, coerentemente alle sue premesse, interpreta come limite teorico, nel ribadito legame con la vita materiale che impedisce al jazz di de-realizzarsi facendosi assorbire nel puro pensiero. Nessuna episteme infatti, nessun ottimismo dialettico può comprendere una musica in cui anima e corpo convivono paritariamente: Body & Soul, per l'appunto.
Ma non basta. La posizione antimetafisica e antiplatonica del jazz incrina l'ordine simbolico occidentale anche nel suo riferirsi a una discendenza al femminile. Non solo nella prospettiva aperta da Angela Davis, che mette in luce lo straordinario connubio di fantasie patriarcali e potere femminile incarnato da leggendarie figure come Bessie Smith o "Ma" Rainey, ma anche nell'intima natura di "lingua materna" che gli attribuisce Francis Hofstein. Numerose sono infatti le testimonianze di intellettuali e artisti afroamericani i quali, evocando il passato e la genealogia, ricordano di essere stati iniziati all'oralità dalle voci femminili della comunità: che scandiscono il tempo dell'infanzia, danno ordine all'apprendimento e individuano il posto di ognuno nella discendenza. Per lungo tempo schiavizzato e poi emarginato socialmente, non potendo riconoscersi in un'immagine paterna deprivata di ogni autorità, l'afroamericano si è infatti rivolto alla sola figura certa di riferimento, la madre. E in verità, come ho cercato di mostrare altrove assumendo un'ottica di tipo psicoanalitico, parrebbe che gli uomini del jazz abbiano inconsapevolmente costruito una densissima rete di rapporti col versante femminile della loro comunità, affidandosi ad esso per la costruzione della propria identità e per il godimento della propria creatività, e riconoscendo per questa via l'autorità di quello che Luisa Muraro chiama "l'ordine simbolico della madre".
Anche per questo il jazz costituisce una risposta radicale e non negoziabile a una tradizione che fin dalle origini ha preferito il non-essere del pensiero all'essere della vita, anteponendo la fissità del logos al mutamento e alla trasformazione perché ossessionata dal pensiero della morte in quanto evento irrazionale e impensabile. In questo senso il jazz non si colloca dalla parte dell'episteme ma piuttosto della doxa: la sua ontologia non è centrata sulla fissità dell'idea (partitura) ma sul mutare della vita delle forme (performance), che impercettibilmente scivolano l'una nell'altra a piccoli passi, per aggiunte e sottrazioni. Da qui l'importanza degli standards, che i jazzmen trattano alla stregua di veri e propri palinsesti (nel senso di Genette), cioè strumenti utili a produrre il nuovo con il vecchio.
Ma c'è un'ultima, significativa analogia fra la posizione della donna e quella del jazzman: il fatto che siano entrambi portatori di un'altra etica.
In quanto figlia della metafisica, dunque costituitasi a partire da una soggettività che si concepisce come estensione antropomorfica della nozione di sostanza, l'etica occidentale è finalizzata a traghettare l'individuo verso un immaginario completamento, verso un ipotetico e conclusivo riassorbimento nell'essere. Non trovando alcun significato nell'esistenza in se stessa, lo proietta in un'ulteriorità idealmente consegnata alla logica dell'imperativo categorico. Ma così facendo, pensando cioè la libertà come superamento dell'insufficienza umana, l'etica non può che ridursi a mero discorso sui valori, a protesi terapeutica, all'infinita serie dei divieti che caratterizzano ogni discorso morale. Cosicché, da Platone fino a Kant, la logica della prescrizione e del sacrificio ha misurato il falso progresso di una morale del dover- essere tesa a inseguire la totalità immaginaria di una piena realizzazione soggettiva. Negando realtà alla presenza, al qui-e-ora di ogni situazione esistenziale, ha volutamente trascurato la perdita implicita in ogni singola esistenza, il punto vuoto iscritto in ogni destino individuale, il limite estremo rappresentato dalla morte come base imprescindibile di ogni filosofare, elemento oscuro ed enigmatico che occorre tuttavia prendere in carico. Solo la morte infatti mostra i limiti del senso, indica che la finitezza è propria di una condizione umana al cui interno solamente va cercata la libertà. La sostanza dell'etica, una volta sottratta alla natura teleologica della morale, non può prescindere dall'assunzione della morte come perno di ogni riflessione, e dalla conseguente accettazione della dolorosa condizione dell'esistenza, del dolore come anticipazione della morte stessa. Tale assunzione soltanto può valorizzare la dimensione della presenza a scapito dell'illusione della trascendenza, poiché concependosi come ideale l'esistenza si manca precisamente come presenza; allo stesso modo per cui concepire il tempo della vita come immerso nel suo proprio divenire impedisce di continuare a riferirsi alle metafore spaziali dello 'sviluppo' e del 'progresso' per farsi carico dell'instabilità propria della condizione umana. Non a caso Julia Kristeva definisce 'ciclico' il tempo delle donne, distinguendolo da quello teleologico e prospettico in cui gli uomini si identificano e con cui pensano la storia. Poiché ogni concezione lineare e proiettiva del tempo, enfatizzando le cause prime e gli scopi ultimi, toglie valore all'intervallo che li separa, cioè al ciclo della vita.
Ora, se la presenza della morte aleggia costantemente nei testi blues quale insostituibile referente della black experience, fantasma ossessivo di una condizione esistenziale e della sua sublimazione poetica, è anche vero che nel momento della performance il jazzman si trova in prossimità, quasi in confidenza con la morte, nella misura in cui improvvisando attua la sua vertiginosa sfida al tempo: raggrumandolo in un istante o dilatandolo in un flusso interminabile. Senza dimenticare che la ritualità del compianto e della lamentazione espressi nel blues e nel jazz - che Giose Rimanelli in suo saggio avvicina a quello delle popolazioni del meridione italiano - non costituisce solo la testimonianza del dolore per una perdita, ma in quanto tentativo di superare l'angoscia della morte avvicinandola a sé, di rendere più familiare la sua estraneità, entra nel gioco dell'organizzazione formale: da Poor Eric di Larry Williams a I Remember Clifford di Bennie Golson al Requiem di Lennie Tristano. A parere di Xavier Daverat ciò segnala la tendenza del jazz a vivere la prossimità con la morte come familiarità con i morti, nell'ottica di una commutatività fra gli esseri che determina il carattere ontologico di tale prossimità. Il compianto musicale diverrebbe così il momento in cui l'interprete, non potendo giungere allo stadio supremo di vivere la sua morte, "non si accontenta di sentire la morte come imminenza, ma l'assume come contingenza della sua propria esistenza".
Opponendosi al tempo finalizzato e intenzionale, decostruendo le metafore dello sviluppo e del progresso, il jazz mostra dunque di ignorare le ingiunzioni dell'imperativo categorico; accettando la finitezza dell'essere, la quota di 'male' costituita dal limite invalicabile della morte, riesce a impossessarsi del suo presente ("Non suono per l'eternità - dichiara Duke Ellington - e nemmeno per il domani"); assumendo quale orizzonte di riferimento l'unicità delle singole esistenze e la pluralità dei saperi, rifiuta inoltre di iscriversi nella categoria dell'universale tanto cara alla metafisica. In questo la sua condizione è del tutto simile a quella della servetta di Tracia. E come è accaduto a molte servette, in una certa fase della sua esistenza è stato considerato portatore di degenerazione morale, e attaccato per ragioni etiche prima che estetiche: musica dei selvaggi lo si disse, cioè di coloro che non conoscono la civiltà, ma ancora più sottilmente musica barbara, cioè di coloro che conoscendo la civiltà la rifiutano attaccandone i presupposti. Accusa a cui gli afroamericani hanno potuto rispondere solo con la dolorosa e insistita necessità della loro arte, visto che da sempre il potere dell'interpretazione è legato alle forme del potere. Un'arte che nella sua contingenza appare assolutamente istituita dalla necessità del suo destino e, volendo usare una terminologia heideggeriana, proprio per questo in grado di realizzare l'evento di un'apertura, di farci intravedere un altro mondo.
Ma al di là delle illusioni del soggetto occidentale, della sua volontà di potenza e delle sue aspirazioni universalistiche, l'etica jazzistica si apre alla singola e concreta esistenza individuale mediante la prassi dello scambio, l'apprendimento per modelli, la personalizzazione del suono, il senso dell'autorità basato sul libero riconoscimento delle capacità individuali. Senza contare il fatto che la pratica artistica, per la donna come per il jazzman, consente loro non tanto di elaborare una soggettività preesistente e riconosciuta, quanto di verificare lo spazio e la possibilità stessa del costituirsi di un'identità: operando sul bordo oscillante fra necessità e godimento, sull'incerto crinale fra etica ed estetica ("La musica Negra - scrive Amiri Baraka - è essenzialmente espressione di un'attitudine, o d'un insieme di attitudini, relative al mondo, e solo secondariamente relative al modo di far musica"); sottraendosi alla logica del valore - nel senso di una morale kantianamente tesa al dover essere quanto in quello di un adeguamento al canone estetico; facendosi infine carico della "centralità ontologica dell'esperienza del dolore" (Massimo Recalcati), esperienza quanto mai enigmatica e intraducibile il cui oblio - o, se si vuole, la cui rimozione - è fra le cause più frequenti del trionfo della retorica. Nella tradizione delle donne, come nella migliore tradizione del jazz, è proprio la paideia del dolore a costituire la base per orientarsi, per vivere la presenza come vera realizzazione dell'essere, superare la nozione comune del bello e del buono in vista della possibilità di abitare il proprio desiderio, desiderio di un'arte vissuta come luogo dell'identità e dunque sola possibile dimora.
Tale segreta energia pensante attraversa e sostiene la musica afroamericana, e non è il minore fra i paradossi della modernità che da un popolo di schiavi sia venuto uno dei più radicali attacchi all'estetica occidentale e alla morale dell'imperativo categorico.
Dall'utopia di un'etica che assume la scandalosa presenza del dolore come emblema della finitezza umana nasce dunque l'atopia del jazz, quel dislocamento simbolico che lo rende eccentrico e inassimilabile alle coordinate filosofiche occidentali, determinandone al contempo la forza e imponendolo come modello. Modello forte e in quanto tale fortemente contrastato, poiché ogni etica pone dinanzi a una scelta ovvero, lacanianamente, impone all'altro una certa forma di divisione soggettiva.
Da qui la luce jazzistica diffusa su tutto il Novecento musicale e artistico, che ha oltrepassato barriere di genere e confini disciplinari in forza di un'incontenibile carica mitopoietica. Di ciò recano traccia le parole di Michel Leiris, che nel 1939, ricordando l'arrivo del jazz in Europa nell'immediato primo dopoguerra, sottolineava il potere quasi magico di una presenza al contempo antica e moderna, la nostalgia appena celata dietro un'apparente frivolezza, la capacità di accomunare, di dare forma ai desideri inespressi: "Con le violente zaffate d'aria calda tropicale, il jazz trasportava sapori di una civiltà antica e insieme moderna, capace di esprimere al meglio lo stato d'animo di molti di noi: demoralizzazione più o meno conscia nata dalla guerra, ingenuo stupore davanti ai vantaggi del progresso, gusto per lo scenario contemporaneo in tutta la sua precarietà, abbandono alla gioia animalesca di subire l'influenza del ritmo moderno, inconscia aspirazione a una vita nuova o a uno spazio più vasto. Il jazz dava forma al nostro desiderio ancora inespresso". Ecco: la forza di quella musica, oggi forse meno di allora, sta tutta nella capacità di dare forma all'inespresso, di mettere in campo quanto resta impensato nell'arte e nell'estetica contemporanee, infine nell'energia a tratti disperata che la sostiene consentendogli di abitare l'utopia del proprio desiderio. Grazie a ciò essa è riuscita a essere contemporanea al proprio tempo, come sostiene Leiris, fornendo un'inesauribile riserva di metafore per pensare la modernità.
Di questa posizione etica, di questa forza morale, tutti ebbero percezione fin da subito, e questo ha motivato tanto l'accanimento dei detrattori quanto l'entusiasmo dei sostenitori. Ma certamente le menti impregiudicate che lo videro affermarsi già a partire dagli anni Venti non esitarono a riconoscerne il valore. A parte le testimonianze dei maggiori artisti e intellettuali europei, basti sottolineare i lampi d'intelligenza che riverberano dalle pagine degli autori italiani qui antologizzati: Alberto Savinio coglie a volo la promessa di una musica in grado di risvegliare Euterpe dal suo lunghissimi sonno; Carlo Belli ne afferra il carattere enigmatico e interlocutorio; Alberico Sala ne dichiara la forza insostituibile di modello; Massimo Bontempelli ne individua la forza morale nell'accettazione del limite dell'esistenza, nella capacità di porsi lucidamente di fronte al pericolo della fine e all'annichilimento della morte. Per questo Jean-Pierre Martin, riflettendo sulla mitologia moderna della voce all'interno della tradizione letteraria novecentesca, segnala l'insostituibile, pervasiva presenza del jazz nella letteratura contemporanea: da Beckett a Céline, da Queneau a Joyce, da Cendrars a Perec. Ciò vanifica ogni domanda idealistica riguardo la sua natura. Se è vero che ogni etica, intesa come risposta responsabile al desiderio, implica il passaggio all'atto, il jazz esiste attraverso la rete di relazioni simboliche che ha posto in essere. Qualsiasi discorso filosofico che lo riguardi dovrà dunque rinunciare al dualismo platonico, agli universali kantiani, all'hegeliana sintesi dialettica e in generale alle categorie figlie della tradizione metafisica. Più utilmente potrà forse ricorrere a temi nietzschiani: a quello dell'eterno ritorno (se è vero, come afferma Deleuze, che esso non elabora un pensiero dell'identico ma piuttosto dell'assolutamente differente, rivendicando il suo statuto al di fuori della scienza e affermando il principio della riproduzione del diverso), oppure a quello della filosofia come genealogia (facendo magari attenzione a non pensare l'origine, dunque il legame con l'originario, come luogo della verità e della purezza, ma dando spazio alle forze che generano il movimento ininterrotto dell'esistenza).
Se infine il "fiume della melodia" - così Hölderlin chiamava l'amato Danubio - di cui parlava Max Roach ha arricchito le genti incontrate nel suo cammino, questo non autorizza alcuna indagine sulla sua 'essenza', piuttosto spinge a verificarne le implicazioni e le ricadute sul piano etico ed estetico. Fatica inutile oltre che destinata al fallimento, nel caso del jazz come in quello del Danubio, sarebbe tentare di individuare con esattezza la sorgente, poiché a monte l'identità si perde in mille differenti rivoli. Come sempre, il problema resta quello del senso.
Giorgio Rimondi