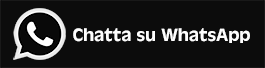Il sentimento religioso di Bruckner
Noi, recenti orfani del Novecento, abbiamo sostituito riti antichi con nuovi, ma non abbiamo conservato il sentimento del sacro. Già in declino un secolo e mezzo fa, si trovava tuttavia qualche convinto testimone.
Come Anton Bruckner, rivolto per predestinazione verso l'invisibile, con il conforto di una comunità che segue coralmente le tracce spirituali dei padri. Egli rende solenne ogni cenno compositivo come l'ostensione di un calice.
Ad Ansfelden, in quel paese di contadini dell'Austria del Nord, provinciale e chiuso seppure non lontano da Vienna, la musica nella seconda metà dell'Ottocento era non solo servizio ma anche sentimento religioso.
Bruckner, ormai maturo e affermato, non dimentica tutto questo nel comporre il Te Deum nel 1881. Lo crea di getto, come quando, stretti da un'emozione intensa, ci viene l'impulso di scrivere una poesia. Ma lo rivede per quasi tre lustri, come per ripensare molte volte al modo di ringraziare per un lascito importante.
Nell'opera investe non solo tutto il suo credo, ma anche il patrimonio linguistico musicale appreso dalla tradizione sacra: un modello gregoriano di vocalità, evoluzioni virtuosistiche tipiche di certa decoratività tardo-barocca, preziosa polifonia rinascimentale. Si cimenta nell'ordire una fuga intricata e vorticosa, ma si serve con sapienza di una coralità spiegata, tripudiante.
La scelta degli strumenti partecipa alla gran festa di devozione. L'organo aggiunto in funzione di pedale è lo stagno nel quale si riflette la sonorità di tutta l'orchestra bruckneriana, immenso organo dai registri lucenti, tanto pronti al clamore quanto a nascondersi sotto un discreto e tenero recitare delle voci soliste.
L'accostamento Te Deum-Nona Sinfonia, non fa che assecondare il pensiero mai realizzato del compositore di adattare l'opera sacra a finale suggello dell'ultima sinfonia. Del finale restano invece una quarantina di pagine. Invero alla foggia di un'opera d'arte concorre anche il caso, e l'incompiutezza assume un valore significante: l'ultimo movimento resta un lungo adagio, vario come la fantasia riepilogativa di un'esistenza intera. Il quadro dissolve come il rassegnato svigorirsi del soffio vitale di fronte al dubbio irrisolto tra lodare Iddio perché la morte è vita o maledirlo perché la vita è morte.
Bruckner sapeva che sarebbe stato l'ultimo lavoro: i precedenti di Beethoven e Schubert rappresentavano più che un presagio. Per questo lo pensa grande, testamentario, ricco di lasciti e autocitazioni. Sarebbe un patetico memoriale se lo spirito forgiante non si fosse prodigato per rigenerare quella materia - già impiegata - per una forma nuova. La lentezza senile nel comporla gli è di peso, ma leggero è il pensiero di Dio, cui rivolge, con candore e coraggio, una dedica.
La partita compositiva è giocata da due contendenti archetipici della musica: il ritmo battente e il canto corale. Un confronto senza fusione: natura-uomo, vecchia storia di parentele difficili, di figli irrequieti e madri matrigne. La conciliazione non è credibile per un artista che ammicca alla modernità e usa un linguaggio che guarda al futuro. È così che il canto tocca intervalli distanti, gli ottoni non temono di cozzare contro dissonanze aspre e squillanti, i bassi brontolano spesso cromatismi enigmatici e oscuri. Il ritmo nello Scherzo è ossessivo e straniante, ricorda Stravinskij.
Di fronte alle manieristiche dimensioni delle opere di Bruckner, come agli affreschi michelangioleschi o ai capolavori mantovani di Giulio Romano chi assiste si può disporre in due modi: lo stupore d'impatto - forte ma animalesco -, per la varietà e l'abbondanza di colori e di forme, oppure lo sguardo analitico, che sposta il fuoco ora su un particolare ora verso un suggestivo angolo della campitura. Consiglio il secondo, che permette di rinnovare ogni volta l'ascolto con sfumature differenti senza perdere la visione del tutto. Il primo dura come il botto di un fuoco d'artificio, l'altro si distende come un orizzonte pensoso.
Da www.sistemamusica.it