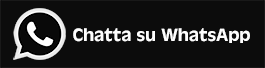Clementi e Horowitz
Non sono assolutamente certo che Muzio Clementi sia stato un grande musicista. Non so nemmeno, del resto, cosa conferisca ad un artista la caratteristica, così appassionatamente amata dal pubblico, di "grande". Di sicuro certo il musicista romano non ebbe quella personalità numinosa che fa dire ai posteri che il genio artistico riscatta l' umanità dal peso atroce di tanta ottusa ferocia e lugubre opacità così oscuramente disseminata lungo lo sterminato scorrere della storia umana.
Probabilmente, se al di fuori di personalità realmente decisive per le sorti dell' arte, si evitasse di cercare quantificazioni e comparazioni, si potrebbe più facilmente individuare nei musicisti quel loro ruolo fondamentale di trasmissione di una conoscenza in perpetuo divenire.
Clementi è stato un anello fondamentale di questa catena che ha garantito e garantisce tra noi la presenza del linguaggio dei suoni. Di ciò ha dato immodificabili certezze la ricerca di questo secolo e l'opera appassionata di alcuni esecutori. Per di più ha fondato, codificandola in stilemi quasi immutati per due secoli, la figura del pianista, del grande artigiano della tastiera, ma anche del Maestro di pianoforte, o meglio come diremmo oggi del guru, pronto a trasformare banalità quasi indecenti in messaggi misteriosofici carichi di presagi arcani e di precettistica difficilmente ricusabile, ma espressa con toni insopportabilmente pedanti. L'antica, ma reale immagine della attempata "signorina di piano", ossuta, dotata di matita per affollare di correzioni di errori e di bacchetta da usarsi con stizziti colpi sulle dita degli allievi più renitenti e più perseveranti negli sbagli, è di stretta derivazione clementiana. Grandezze e miserie convivono, si sa, ma il musicista romano mostrò le une e le altre in modi assolutamente inconsueti, anche se ben radicati nel clima del tempo che attraversò.
Ciò che di questo musicista è stato scritto, anche nel caso del più recente e ben documentato studio di Louis Plantinga, é però sempre stato concepito se non proprio sotto il segno dell'agiografia, quantomeno, del lavoro costruito sul presupposto di un giudizio estetico deciso a priori, al di fuori di ogni possibilità di essere posto in discussione. Anche questo è un modo per quantificare l'opera d arte, dandole un apprezzamento preventivo, come se bastasse solo il tempo e il suo scorrere tra una patina e l'altra a dare dimensione e spessore al lavoro di un musicista nato quasi 25O anni fa.
Bisogna poi i ricordare che Muzio Clementi, da sempre, salvo le solite eccezioni che ogni statistica prevede, è il personaggio meno amato dai giovani. L'osservazione è meno banale e demagogica di quanto sembri. Anche Dante e Manzoni nelle scuole italiane vengono generalmente rifiutati, salvo poi essere riletti in età adulta e amati come eterni contemporanei. A nessun musicista maturo invece potrà mai venir in mente di riscoprire Clementi con lo stesso ardore che può giungere rileggendo da adulti Foscolo o Nievo, divenuti subito insostituibili compagni del nostro viaggio. E il motivo di ciò non va cercato solo nell'opera sua didattica che inevitabilmente contiene rigidezze ed aridità. Anche nelle composizioni dedicate alla formazione ulteriore del pianista e a quelle di dichiarato impegno artistico, é possibile cogliere una sorta di sinistra vocazione a fornire dei fac simile di bella musica, degli abilissimi surrogati dotati delle più pregevoli rifiniture e dei più ingegnosi accessori.
Se poi ci si imbatte in qualche sua dichiarazione scritta è facile cogliere il nesso tra l'untuoso moralismo delle sue righe e l'inamidato e algido procedere delle sue frasi musicali. Erik Satie aveva compreso tutto ciò manipolando con algida perfidia la celeberrima Sonatina in do maggiore, a cui conferì il titolo di Sonatine bureaucratique dopo averla provvista di parole volutamente idiote, da recitarsi col tono del nonsense.
Eppure Muzio Clementi è sepolto nel chiostro dell'Abbazia di Wetminster, onore riservato solo alle massime personalità. La sua "voce" nei migliori repertori bibliografici internazionali ha l'ampiezza ed il rilievo dato ai più famosi artisti di ogni tempo. E stato indiscutibilmente il fondatore del pianismo e grazie ai numerosi allievi, praticamente di tutte le scuole pianistiche europee. Stimato da Beethoven e Cherubini, ebbe vita complessa, ricca di contraddizioni, sempre in bilico tra perbenismo pedante e spericolatezze da avventuriero.
Coloro i quali sarebbero magari tentati di definirlo con frettoloso vezzo contemporaneo un "grosso musicista" ignari del fatto che Guido Ceronetti, ferito dall'abuso di questo aggettivo, afferma di pensare sempre, quando lo legge, ai sacchi condominiali di spazzatura) potrebbero anche considerano "intellettuale organico" per quel suo spaziare tra composizione, attività didattica, editoriale e da imprenditore ben avveduto.
Autore di varie pagine, anche sinfoniche, poco o per nulla conosciute, può forse ancora attendere una rivalutazione piena al di fuori di stime o detrazioni preventive. Il lungo e devoto lavoro di ricercatore di Pietro Spada ha già portato incoraggianti sorprese.
Uno degli iniziatori degli studi clementiani fu Giulio Cesare Paribeni, musicista colto e raffinato (una sua composizione L'usignoIo del Sassolungo fece parte del ben selezionato repertorio di Furtwängler).
Paribeni nel 1919 pubblicò una monografia su Clementi. L' epoca giustifica un certo orgoglio nazionalista nel ripensare al ruolo del nostro musicista nato a Roma nel 1752. In queste pagine appaiono comunque evidenti i termini musicali, ma sarebbe più opportuno dire '"scientifici" in base ai quali è possibile senza interferenze di inganni o di retoriche supervalutazioni, pensare a Clementi come ad una tessera essenziale per la pienezza del divenire del mosaico storico.
Paribeni era amico di famiglia. Intimo di mio nonno veniva immancabilmente a casa nostra alle 17 di ogni domenica, salvo il periodo dei bombardamenti e dello sfollamento. In famiglia si favoleggiava che in tempi migliori, nonostante la ben radicata abitudine, egli si facesse in ogni caso precedere da un proprio biglietto da visita piegato nell'angolo alto a sinistra per significare ottocentescamente la richiesta di visita.
Nel 1947 io stavo preparando l'esame di corso medio di pianoforte; i fatali 23 Studi clementiani per il Conservatorio contendevano il tempo agli aoristi del Liceo. Dopo il té suonavo per l'anziano e illustre ospite. Quando leggevo poi anche Clementi, eseguivo tutto alla ricerca della velocità massima, un po' perché non ci trovavo nulla di interessante se non una sorta di affermazione atletica e un po' perché il tutto sarebbe comunque durato di meno. Il Maestro scuoteva la testa. "Sei troppo giovane, ma un giorno capirai che potrai eseguire una pagina come questa con lo stesso piglio drammatico di una Sonata di Beethoven o un suo Adagio come se fosse Schumann.
L'indice ammonitore non mi incoraggiava a prendere sui serio quella che per me era una patetica perorazione il cui unico esito, al momento, era il farmi perdere minuti preziosi della radiocronaca dì Nicolò Carosio che non mi facevo mancare nemmeno in quegli anni di studio accanito. Un dribbling di Carapellese ed una "percussione" di Nordhal, raccontati dall'aedo del "wiscaccio" e del "quasi goal", non valevano tutti i cento brani del "Gradus ad Parnassum".
Molti anni più tardi mi capitò di ascoltare un disco di Sonate di Clementi eseguite da Vladimir Horowitz. Tutto ciò che suonava questo strepitoso interprete era sotto il segno di una ricerca personalissima situata sempre oltre i limiti delle estetiche convenute. Anche il suo modo di eseguire Clementi mi sembrò paradossale.
Avvertii la dialettica dei fortissimi contrasti, i bagliori di una tecnica che confinava con l'illusionismo, i turbamenti e le flessioni di un fraseggio assolutamente e per me, allora, ingiustificatamente personale, ma non mi venne in mente l'antico monito di Paribeni. Insomma non mi accorsi di perentorietà beethoveniane o di ombre schumanniane, nemmeno quando quelle pagine venivano lette dal maggior pianista del secolo.
Fui poi io stesso esecutore poco convinto di alcune Sonate di Clementi quando agli inizi della carriera, specialmente in America, mi si chiedeva di eseguire programmi di musica pianistica italiana.
La prima volta che ascoltai dal vivo Horowitz scordai completamente quel suo disco clementiano inciso nel bel mezzo della sua assenza dal palcoscenico durata quattordici anni, che pure fu solitaria, ma significativa presenza di una luce di suono nel mare opaco di una profonda crisi depressiva.
Era domenica 9 maggio 1965, alla Carnegie Hall, il giorno del suo inatteso ritorno al concertismo. In programma non figurava Clementi, ma la presenza del musicista che tutti ormai sapevano tanto pregiato dai pianista russo era latente, sospesa nell'aria come se il primo e il postremo tra i virtuosi della tastiera si fossero incontrati per un addio al pianismo mitologico, per un ultimo sguardo ad un mondo disposto a credere ad incanti così sontuosamente e genialmente costruiti.
Il pianista russo, che avevo visto storcere ostentatamente la bocca a qualche piccola nota falsa del "rivale" Rubinstein sfuggitagli due mesi rima nella stessa sala, fin dall'inizio subì l'atmosfera particolarmente eccitata. I fantasmi, ai bambini e a chi ci crede, dànno sempre paura. Alla quarta nota arrivò una clamorosa "stecca". Chiunque si sarebbe definitivamente scoraggiato. Horowitz riuscì a far appello a potenzialità segrete celate all'interno delle proprie nevrosi e depressioni. Fu anche il trionfo dei valori della "scuola", del mestiere, clementinamente intesi. Trionfo pagato al prezzo del totale estraniamento dell' uomo dal musicista. Quel pomeriggio fu anche la vittoria dello studio accanito, di una volontà più forte di una colite psicosomatica mai in realtà domata, di una nevrosi disperata che faceva accettare una disciplina di ferro, da lager come la conobbe di certo il giovane Clementi nei suoi primi anni di apprendistato in Inghilterra. Era stato l'avvenimento musicale più stupefacente a cui abbia mai assistito. Certo che il ritorno di Toscanini alla Scala, il Tristano diretto da De Sabata o il Wozzek da Mitropoulos erano stati momenti di ben altro spessore. Ma in quel giorno il pianismo leggendario di Horowitz radunò tutte le componenti di un mondo che poteva esistere solo a New York in quel tempo, per il quale sembrava non fossero esistite guerre, stragi, mutamenti epocali di cultura e di costume. Sbucati dalle tende dove si erano accampati in coda quarantotto ore prima, rifocillati dai thermos di caffé portati da Wanda Horowitz e dalle sue amiche, i primi fanatici estimatori del pianista russo, con volti tragici da naufraghi, latori negli sguardi delle più allucinate didascalie skrjabiniane, si avvicinavano al botteghino dove finalmente erano stati messi in vendita i biglietti. Altri fantasmi, scesi da limousines dalla nera eleganza funeraria, scivolavano verso l' ingresso alla platea, alzando l'ambito lasciapassare come in un ostensione di icona venerata. L'aspetto di revenants era accentuato da tenute impeccabili, forse, ma più adatte trent anni prima. Lo stesso passo delle dame in lungo era fluttuante, senza scatti, come se fossero state issate su rotelle. Gli uomini affacendati e orgogliosi certo del loro ruolo di testimoni dell' "evento", rivelavano, in prevalenza, una sconcertante estraneità al fatto che pur sempre era musicale, vissuto con la stessa imbarazzata cerimoniosità che si vide chiaramente nei visi da alieni degli "invitati" alla celebre Messa per Gianni Versace in Duomo a Milano.
Il concerto fu straordinario e certo riuscì a vincere quel ché di vuoto e nevrotico che vi alitava intorno. Dopo l'ultimo bis vidi sparire dietro la porta che conduceva al camerino le code ondeggianti del suo tight e così finì il concerto. Anche l'abito era stato importante, presenza assolutamente teatrale che dava completezza all' immagine, così come il frac la conferiva ad un altro grandissimo virtuoso, Alfred Austerlitz, in arte Fred Astaire, lui pure protagonista di un altro fatale epigonismo.
Clementi era stato anche quel giorno per il nostro pianista un punto fermo, il riferimento maniacale ad un antico codice di comportamento del concertista. Le norme della tenuta formale derivavano dal musicista romano che sul pianoforte aveva deciso tutto, anche i modi dell'abbigliamento. Lontano dai casacconi informi di Haendel e dalle stilizzate, ma striminzite giubbe di Haydn, Clementi aveva imposto al concertista un aspetto esteriore non certo sgargiante ed appariscente, ma in piena linea con un concetto di britannica dignity. Il primo sistematico professionista della musica, solo pochi anni dopo che i musicisti avevano dismesse le livree degli aristocratici, lanciava una moda a cui il solo Paganini, il grande trasgressore, in parte almeno si sottrasse se è vero che il suo frac, come ricorda Heine, sarebbe stato accettabile solo alla corte infernale di Proserpina. Quella moda era però giunta oltre la metà del secolo XX, per estinguersi forse proprio con Horowitz, ultimo latore del messaggio clementiano di rigore formale, dandy nevrotico per il quale la forma è l' unica sostanza possibile.
Dopo il concerto del 1965 Horowitz riprese una moderata attività, molto dedicata comunque a colpire i mezzi di comunicazione di massa. Vi era un'immagine da ripescare nei precordi. Bisognava rinfrescarla, imporla. Tutti hanno visto le sue fotografie con clamorose, clawnesche cravatte a farfalla. Smetteva il tight dei concerti, invariabilmente pomeridiani, per cercare di assomigliare ad un attore di cabaret intento a sciorinare di continuo motti, frizzi in un pub sofisticato. Moni Ovadia, se non lo trattenesse probabilmente un istintivo ritegno da attore gentiluomo e dolente, e se mai lo avesse visto in azione, ne potrebbe fare un ritratto preciso, gustosissimo. Il suo gusto del witz tragico, di un understarement devastante, avrebbe colto verità furtive, ma reali del nostro musicista.
La conversazione di Horowitz negli anni '70 (le numerose interviste televisive confermano ciò ) era un collage di gags, di improbabili mitologie tese alla creazione di una propria immagine vistosamente restaurata, cosi come quella dì Clementi degli ultimi anni era stata una sequenza, in volontariamente umoristica, di inamidati precetti moralistici, di verità ricostruite secondo un'idea artefatta di perbenismo dei musicista.
Nel 1971, ebbi occasione di avvicinare Horowitz di persona.
La Lincoln scivolava adagio lungo la strada sterrata che saliva da New Milford lungo il bosco. Eravamo in anticipo. Il viaggio da New York verso il paese del Connecticut dove, insieme a mia moglie e all'amico Julius Bloom avremmo incontrato Viadimir Horowitz, era durato meno dei previsto. Erano passati sei anni da quel suo concerto.
L'appuntamento era stato fissato alle 17 esatte di una domenica d'estate. Valodia come lo poteva chiamare solo Julius, suo amico intimo e agente personale e a quel tempo una sorta di mio consigliere e impresario, ogni giorno alle 15 compiva un percorso di due ore esatte di footing e per nessuna ragione al mondo avrebbe interrotto o accorciato la propria passeggiata. Tre ore di studio giornaliero e due di addestramento fisico erano i cardini delle giornate del pianista nella sua villa del New England. Come mi aveva avvertito Julius Bloom, mentre riguardo allo studio era disposto persino a scherzare, per il footing era intransigente e fanatico. Usava, appesi al collo, contapassi, misuratore delle yarde percorse, cronometro e in tasca una cartina dei boschi con i percorsi segnati in colori diversi secondo la velocità prestabilita.
Avevo visto per caso più di dieci anni prima gli allenamenti di Pietro Dordoni, Campione olimpionico, atleta da leggenda, ma tirato su a panini fatti dalla mamma. Li divorava al termine dei lunghi sentieri ancora verdi lungo l'Aniene che inanellava di corsa, dopo essere stato frequentemente interrotto da qualche tifoso con la rituale pacca sulle spalle e da amici fidi che gli mettevano in mano borraccie di acqua minerale. Dordoni le sorseggiava rallentando un po' la corsa per meglio apprezzare il refrigerio; poi ne versava il resto sulla nuca e quindi, chinandosi un po' come per cercare un improbabile cestino dei rifiuti, la gettava con garbo nel ciglio della strada là dove l'erba era più alta. Spesso rientrava sulla canna della bicicletta di un amico.
La Lincoln, con gravità, sempre diminuendo l'andatura, macinava le foglie secche sulla strada così lentamente che si sarebbero potuti percepire i disegni delle venature e il rilievo del gambo pigiati dai pneumatici. Guai. però arrivare e farsi scoprire in anticipo. L'incontro sarebbe potuto sfumare per una delle rare, ma comunque leggendarie irritazioni del pianista. Finalmente, al fondo di un rettilineo, ci sembrò di intravedere una sagoma umana che poteva essere quella di Horowitz.
Julius Bloom decise di chiedere allo chauffeur di fermare la macchina e di farla accostare parzialmente nascosta dalle piante.
Avevamo da poco sorpassato la casa estiva di Arthur Miller e dopo quella di Horowitz, in una tenuta più grande, abitava Friedrich March. - "Tre grandi americani d'oggi" - disse Bloom - e siccome egli non era uomo da parlare solo per l' ufficialità, aggiunse - "tre grandi pazzi."
"Uno, sconvolto dal rimorso per la morte di Marilyn Monroe di cui non sa darsi pace. L'altro, un tempo lo sì poteva considerare il più ben l'uomo del secolo, ma oggi si sente dimenticato, travolto e sopraffatto dall'ultimo imbecille di Hollywood che esibisce spudoratamente una faccia fatta solo di tic e smorfie, poi Valodja, lo vedrete, è il più tranquillo dei tre, sempre il più grande e il più matto."
Mario Delli Ponti