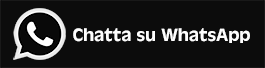Carmelo Bene: del musicale "Tutto il teatro comincia nell'addio"
Nel sorriso del tragico travestito in musica. Perché c'è solo la musica. Questo è l'assunto che ci lascia Carmelo Bene - eredità fin da ora non capitalizzabile, monumento senza effigie, sarcofago senza spoglia, epicedio senza voce -. Sembra poco e anzi: lo è.
Non c'è teatro se non nell'addio. Non c'è musica se non nell'addio, come chiosava amaro Adorno pensando a Berg... Insomma allora addio al teatro, addio alla musica. Addio a Carmelo Bene... da che ogni scena è scena funebre, culla simulacrale in pozza blu della rappresentazione che non c'è, non c'è mai stata.
Carmelo Bene è morto. Vale per dire che non bisogna per forza defungere per meritarsi un funerale... sembra di sentirlo intonare: "LA MORT (leggi la mor = l'amor alla francese)... Ma la morte è la vita, anzi prenatale, quando noi s'è feto noi siam già fetenti, nel senso che noi abbiamo già questo olezzo di morte, e questa nascita non è una vera nascita; è già la morte che è incominciata... La vita è un coma, nevvero? Un coma che inizia nelle acque maternali e poi s'arriva alla morte della morte. Perché è la morte che muore, noi non si muore, noi non si muore più... La morte non esiste, è impensabile, non si pone; è chiaro che ci sono delle agonie, ma tutta la vita è un'agonia e poi con tutte le malattie dolorose, questi fastidi che sono appunto fastidiosi. La morte è lei che muore. Come sincera Lorca al torero morto 'Tu es muerto para siempre', cioè per sempre è importante. Non quest'anticamera della morte. 'Che muoia la morte', così urla il Tamerlano, il great, lo zoppo, il Timur della superba pièce di Christopher Marlowe..."
Ecco dunque che la musica morente è dapprima il parlare di musica oggi, anzi il 'parlare'. Oggi come ieri, dopo la scomparsa di Carmelo Bene, parlare è orrendamente difficile. È impossibile sproloquiare del modo di un'arte che è puro radicale alieno, in colloquio coi millenni e con le forme; non con i siparietti delle circostanze maldestre e ossequiose della nostra piccola parrocchia culturale, fogna mestierante di burocrati, di direttori artistici, di organizzatori-banchieri, in che si bagna la fronte d'un'estrema unzione ogni teatro e ogni musica praticabile.
Carmelo non era un musicista a rigore, non era neanche un attore e non era un artista. Non era e basta. Per chi è consapevole della invisibile parodia, celata in filigrana dietro il rito antropologico di una vita, di un'idea di teatro, di una mossa azzardata di pensiero a spossessare il divenire delle mode, degli 'ismi', per incastonarsi in una segreta calotta di segni che dialogano tra di loro. Una comunità silente di affinità elettive, sempre più lontana e a latere, comunità dell'ascolto di chi 'non c'è', di chi 'è altrove', pacificato in conversari intimi.
Chi conosce questi guasti dell'attenzione discorre con un linguaggio perfettamente normale eppure assolutamente incomprensibile, nella 'lingua straniera di casa' di Proust, in un dialogo privato in mezzo alla piazza principale.
Parlare di musica oggi è questo 'sussurrarsi all'orecchio' dell'Epitteto in mezzo al querulo cicalare altissimo della piazza mercantile. Dire di Carmelo Bene è ormai come dire di Shakespeare o di Debussy o di Bacon: un sibilìo nel vacuo, un appello che si perde e scema. Dire di Carmelo Bene in morte come in vita è un tacer-si, un porgersi le parole monche e troncate, nella pena e nella gioia di un'estinzione dal discorso che non ha luogo e non ha tempo.
La musica e il teatro finiscono. Questo è un fatto. Nelle fauci di mercati assiepati ad ogni angolo di quotidiano e di ottundimenti perenni, non c'è più posto per l'arte e men che meno per i 'capolavori'. E oggi questa fine si è accelerata di molto. È un fatto. Come peraltro è accademia, almeno dai greci in poi, che l'arte sia "... il resto di che mai fu, sia essa prosa, musica, immagine, architettura che nella sua consistenza ingombrante strazia l'aria, siccome svenuta sui gradini di una chiesa magari del Borromini..."
In ogni caso il corteo di un 's'ignora' ha steso il suo sudario su ciò che è 'imparlabile'. Compresi i coccodrilli e le rivendicazioni, gli sdoganamenti e i fasti storico-filologici pronti a scatenarsi nel processo di beatificazione al calendario dei santini nazionali, a cui si assisterà ben presto, come è facile vaticinare. Si dirà d'altro, dunque, facendo finta che Carmelo Bene sia stato a questo mondo e che abbia fatto musica, tra le altre cose, cioè che si sia 'distratto' fra due colpi di dadi, sempre in un entre-deux dove si confessa il nostro scambiarci consolazioni, dando per scontata ogni equivocità e per acquisita l'impopolarità e l'inattualità della musica, così come dell'arte.
Al minimo potrebbe assomigliare a uno spostamento, a un'avventura, questa pretesa di 'dire' e di 'spendere' il nostro conforto, un po' come l'Alessandro carmelobeniano, intento a "... misurare il suo precoce sapere sull'ironia geografica del viaggio stesso".
Ecco... si va a dissennare: Bene da Otranto aveva una voce musicale. E questo dovrebbe autorizzare a blaterare di lui, qui e adesso. Una voce è una voce e nient'altro. Proprio così. Uno strumento capace di 'divertirsi' (da etimologia: uscir di traiettoria, di sé, di senno) in armonia, modalità e intervalli, esattamente come un'orchestra.
Voce è poesia. "... delirio, suono, risuonare del dire oltre il concetto, è intervallo musicale d'altezza in che si dice la delusione di quell'altro intervallo (distanza) tra il pensiero e il suo riporto sulla pagina".
E tra la gigantesca mole del suono tecnologico, bivaccante nelle radure dei vuoti, quella voce si andava da sempre sbriciolando dietro la mareggiata dello spettacolo, come solo un'altra voce è stata forse capace di fare nel secolo, addensata dello stesso dolore 'antico': il canto scuro della Callas. Quella voce ha attraversato la musica e la storia e vi si è infranta, come l'Adelchi che trova sui fondali dell'Opera romantica il cimitero della storia e del poema epico, sgusciato in costumi di tragedia. Questo e non altro è il divenire teatrico di quelle anime che, intransigenti, dialogano con la grandezza nel 'cantar l'ascolto', appartenendo già ai gesti impossibili di questa vita, in cui non c'è mai un'azione che possa realizzare il suo scopo, se non si smarrisce nell'atto. La voce si sporge così fuori dal teatro, dalla musica, dalla scrittura, fino alla poetica dell'ascolto - vera rivoluzione filosofica -, in una zona dove non 'si dice' ma 'si è detti'.
In effetti non si può suonare musica, si può solamente stare in ascolto: "Intendo il teatro come il luogo dell'esser 'detto' nel piano dell'ascolto. Così come la scena è il luogo del 'levar di scena' e la platea il luogo dell'esser 'spiato'".
Se la finzione è fin dall'inizio un chiudere la partita con il sé, con l'io e l'identità, in che stride la 'ripetizione dello spettacolo', la phoné assiepa intorno alla sua stessa risonanza la poca arte possibile, intermittente e 'insignificante' in una differenza. Insomma il 'teatro e il suo doppio' artaudiano sono appena il punto di partenza da dove la parola soffiata del lògos greco tesse la sua trappola: ma la phoné funge da risvolto all'enfasi anfitrionica dell'essere, istoriata nel linguaggio. Anticipando la presenza ontologica in un ritardo... Prima di iniziare a parlare c'è già un soffio che interdice la voce delegittimandola. Un pronome del suono... Un impensabile al centro del pensiero.
Si sperimenti dunque l'aldilà dell'avanguardia, l'aldilà di Artaud, la post-crudeltà per depensare la fêlure centrale, approdando alle variationen dei tagli di lingua, a 'parlare' i gesti e gli oggetti, abitando i suoni e lo spazio: "A tremila anni di distanza ripropongo a teatro il prodigio della phoné. E alle soglie del duemila sperimento l'assolutamente moderno e quindi l'assolutamente antico e quindi inedito: il teatro greco amplificato in maschere e coturni". Quel moderno teatro-lampadario di Baudelaire, inficiato in mascheroni giganteschi, oltre la filastrocca del causa-effetto storico-cadaverica.
Che poi i flirts, la pochade, la prostituzione dell'arte e del miracolo siano all'ordine del giorno è faccenda comune per chi ha a che fare con la teologia. Gli sberleffi e il dandysmo non hanno niente di sregolato, sono il minimo lusso che si può concedere al santo stilita ficcato a capofitto dentro la materia, dentro la religione ritmica. Una facezia di eccentricità che mura in un ritiro chi sa di 'dover mancare per esser-ci'.
Esteta è lo straniero, sdilinquito in un deserto di boccascena, in un Idéal baudelariano, accompagnato dall'Angelo di Rilke o dall'azur mallarmeano o dalla testa di Medusa di Celan, sopportando se stesso umano (troppo umano) solo se oggettivato. Un capolavoro non sa che farsene dell'arte, dunque non può che 'attuare' un costume raro. Sapendo che il suo atto come vera ricerca incontrerà l'effimero, cioè lo scacco, il fallimento, sempre. - Se è così perverso è così puro - e tenta la bellezza in ciò che è oltre.
... così: scialo del teatro, della musica a teatro, del teatro in musica, della musica teatrale... sovrimpressione, dissolvenza, mutamento, divenire delle forme che - in ogni caso - non è storico.
Ecco dunque di seguito e senza soluzione lo squartamento del linguaggio e del senso nella di-riscrittura scenica, la disarticolazione del discorso succubo del significante, il togliere di scena, l'infinità dei doppi, la sartoria e scenotecnica-linguaggio, il rinnovamento del poema sinfonico, la lettura attoriale come non-ricordo del morto pre-scritto, il superamento di Artaud, la sospensione del tragico, il cinema come immagine acustica, la strumentazione fonica amplificata, la macchina attoriale...
Punteggiare, strappare la 'carta' del teatro con la carne, con la ginnastica, con il sacrificio, con una catottrica di geroglifici corporei, musicali e coreografici, in una macerazione cilicea (la stessa di Huysmans, di Sade alla Bastiglia, di Goya alla quinta del sordo...) loyoliana, quasi militare, laddove Artaud si era fermato. La lettura-scrittura di scena si dilata ad ogni prassi di parola e di vita... Così la strumentazione fonica amplificata di Carmelo Bene si arricchisce nel tempo di varie tappe, in un programma puntuale, serissimo e laboriosissimo: si passa dalla 'verticalità del verso' delle letture dantesche, leopardiane, campaniane, agli 'accenti interni del poema' in Majakovskij, nel Manfred e nell'Egmont sinfonici, al 'canto fermo' (firmus) del gregoriano e del lied, al parlato d'opera, all'intenzione musicale, alla dinamica e alle s-modulazioni di frequenza, all'ampiezza del ventaglio timbrico delle suite amletiche, dell'Otello, alle variazioni tonali del S.A.D.E., al puppen-staccato del Pinocchio, all'emissione (petto-maschera-testa-palato-denti-nuca; e non solo naso, come tutti ingiuriano), "sempre 'stretta' nel diagramma monotòno della fascia armonica e del basso continuo mai disinserito", tale da far nevicare in grumi esplosivi l'alone del suono, del Macbeth... La macchina attoriale è la voce che attraverso la strumentazione fonica amplificata 'si atomizza nella risonanza ('voce-ascolto'). E la risonanza arriva sempre prima del suono ('voce udita'): la voce non è il dire, è l'ascolto stesso... un fiato in ispirazione o un fiato trattenuto, un tratteggio vocalico a scriteriare la frastica del logos.
L'infortunio sintattico è perentoriamente completo, nelle spire di una melologia ben oltre lo sprechgesang o lo sprechstimme.
La musica è per Carmelo come un'anestesia, un torpore che spalanca la sensazione, la narcosi di un pharmakon platonico, che separa finalmente dal senso. Musica sono d'un tratto le 'guerre' foniche, filanti, del Tamerlano di Marlowe, dove le frasi sono "... fatte a pezzi, sanguinanti fonemi, deliranti agonie a squarciagola". Nel bagliore corrusco, nelle 'fotografie astrali' del blank verse anglosassone, con il suo claudicare giambico, al di qua della metafora stessa. L'arsi e la tesi boicottano infatti il senso dello scritto e digrignano il versante dell'ascolto come retorica del dire e della rappresentazione:... Artaud, Nono, Hölderlin... Oppure ne Il Rosa e il nero da Lewis, evocato dalle partiture di silenzi di Bussotti (eterne le liti e le condivisioni tra Sylvano e Carmelo), in cui la messinscena avvampa d'usura barocca: "Teatralmente è musica, testualmente è tradimento fedele, di 'orientale' è la Cina esculsa". O ancora nell'elettronica salivata, intercettata sui denti, sulle cavità di palatali o di labiali, ruttata, borborigmata dell'afasia del Macbeth.
Deleuze dirà di questa voce, di questa musica di scena: "È già sprigionare dei divenire contro la storia, delle vite contro la cultura, dei pensieri contro la dottrina, delle grazie e delle disgrazie contro il dogma".Distrazione, miraggi, strazi solitari ripopolati di fantasmi... Carmelo si perde nello scrupolo assoluto, algido, terribile, della scrittura di scena. Suffragato dalla non-volontà di Schopenhauer, da un auto-digerimento di Nietzsche, una volta licenziato tutto il teatro della 'cornice', della 'quadratura' borghese, una volta toltasi perfino la maschera per mostrare un masque ben più sacrale e incontemplabile: la faccia stessa. La Moira dello specchio, oltre il principium individuationis, oltre il velo di Mâya.
L'attore è busto e nient'altro. Fregoliana è la sua goffaggine, l'inciampo, la botola tra regine-soubrette, tra bambine assassine carrolliane, tra Pentesilee cinte di bustier acustici o Salomé mulatte ma selenitiche, tra i palchi ammonticchiati di fiori, tra gusci ossei percussivi, tra maglie di ferro e discariche di storia dell'arte. L'attore è monitor, visiera.
Rotaie acustiche incidono il palinsesto del racconto e lo disseminano in croste musive; la voce è la visiera dell'elmo achillico, il visus segnato dalla mancanza, come l'ingiuria inascoltabile dell'umano - si può esser solo mostri guerrieri o burattini di legno, tronchi neuro-vegetativi, anime-come-fil-di-ferro -. Si può solo essere contro il regista come contro il direttore d'orchestra, nûs anassagoriani che guidano la storia occidentale ontologica in vece di chierici-reggitori, per la messa (in scena) del solito "presepe nostrano" o della solita sincronia-partitura didascalico-dialettica.
... Abissi, regie incenerite del suono, intervalli scavati, rubati, sordine ammutolite, scale e volatine furiose, glissati... saranno questi gli effetti ottici della phoné nei décor del Pinocchio, di Otello, dell'Achille, di Mercuzio, di Gloucester, di Amleto, svariando dai substrati favolistici ai Globe elisabettiani, fino alle mascherine da intermezzo settecentesco... o nelle inquadrature cinematografiche del Don Giovanni (circa 4000) o della Salomé (4500). Una specie di privilegio della dannazione, nei panni byroniani a palazzo Moncenigo: esser cioè minati dalla grazia del vaniloquio... Anche il cinema come la musica di Bene è un'appendice di trapianti, di traslochi metonimici. L'immagine si fa ascolto e l'ascolto immagine. Con il cinema ci si trova di fronte alla 'macchina attoriale' in movimento. Visivi sono i silenzî musicali della voce, e basta.
Corpo, cinepresa e montaggio non sono che strumenti del ritmo, della musicalità dell'immagine. Al pari di Ejzenstejn che usava gli obiettivi come strumenti in un'orchestrazione.
Il suono bofonchia ovunque vuoti e cesure, bautte musiche dell'altro parlante lungo la sospensione del tragico che è il depensamento... Anche della musica, anche del cinema, anche del teatro... Se si raccatta qualcosa è dagli spasmi minerali, dai detriti di tableaux vivants di Tiziano, dai nudi botticelliani delle attrici, di Lydia; in fondo alla spazzatura di citazioni 'basse', fescenniniche che depurano dalla contaminazione, dal mélange des genres, anziché aggiungere.
... venuti al mondo orfani dall'aver affrontato l'altro artaudiano, che ruba l'io e ci espropria: "Mi fu privata anche la voce, la mia bella voce calda forgiata nel tempo... mi era appena concesso in odio all'amplificazione di gridare o di restar muto in ascolto, in attesa di niente", si può permettersi l'economia dello spreco di Bataille, l'illusionismo musicale in fate morgane e 'pose' di tenore fuori registro. È il Pinocchio stritolato in una "distrazione a due voci tra scena e quinta", il Lorenzaccio demussetiano (dove i piani dell'ascolto si impalmano come in un ricercare a tre voci), primo avvento delle morbose intuizioni del fuori-tempo, dell'aiòn, il 'tempo' fuori tempo degli Stoici, il tempo che non lascia eredità o discendenza, che eccede ogni cronologia, ogni testo, ogni cronica nell'anacronismo.
Tempo dell'oblio, del confondere le tracce. Che accoglie il divenire di Deleuze come variazione, come differenza. Come l'aiòn di Giacinto Scelsi. Come il soqquadro di certi cluster materici... Precedenza o tardività che eccede, che non appartiene alla cronologia ma al rifiuto dell'originale, alla musica barbarica dei tirsi bacchici. Ma il dionisiaco e l'orgiastico in realtà finiscono subito di bullare una geburt der tragödie aus dem geist der musik, qui frastagliata in manieri-sagoma barocchi, in baccanali-sabba da camera. "Il nostro Ejzenstejn da camera", battezzerà Cosulich a proposito del corto Hermitage... Il suono è appena l'intimo trucco di un'arte magica, lo 'spavento' stellare di un'eclosione di scena: il suono non proviene da nessuna parte, è lo spazio compitato a geometrie e volumi di vuoto, è lo 'scandalo'della visione, l'immagine che scivola e scompiglia i sensi.
Gilles Deleuze, Pierre Klossowski, Maurizio Grande, Jean Paul Manganaro, Piergiorgio Giacché... per citare solo i più in vista, prendono le difese di questa 'sottrazione'. Prendono le difese di Carmelo Bene, il più grande uomo di teatro del mondo, contro la sordida arroganza papale della critica provinciale e sciatta, palude in cui si dibatte il teatrino e la cultura italiana.
La macchina è antropologica, come vuole Giacché, è cioè una macchinismo che recupera il cabotinage, l'istrionismo, il gesto della 'fine dell'attore' e della 'fine dell'uomo', dell'avvento della macchina desiderante deleuziana anti-psicologica, anti-edipica, del corpo senz'organi in prospettiva di un teatro 'totale'. Ma un teatro totale può solo essere totale come rottura del teatro, emorragia dell'avanguardia. Se c'è un'avanguardia nell'arte è da intendersi semplicemente come cineseria della 'scomparsa': un 'Amleto di meno' è di già pornografia bucata dalla voce, gesto-segmento spezzato, puntillismo d'azione-musica riscoperta in Schönberg.
Cieli come correnti d'aria, vanitas d'occhi nella dipartita dalla scena verso la balbuzie, verso l'amnesia nel prato fiorito delle polifonie, sulla spuma marina di convulsi madrigali contestati. Nel mezzo sta l'eccesso e il mezzo non è la media, è il divenire. Non l'origine. Non l'arrivo, che sono la storia.
La musica di Carmelo Bene sta in mezzo. Nel tam-tam del canovaccio che percuote e mette alla berlina la partitura-testo, la rigurgita a frange, la cartografa a rizoma, ne sbrana la grana con gli ensemble vocali, con le sinfonie di voci altercanti, nei rimpalli degli imi ipogei tra voce e eco, negli intervalli modali, nei bassi ostinati, nel frinire rumoristico. È l'ora del Manfred di Byron-Schumann a S. Cecilia o alla Scala, in cui il suono esce di sé e diventa personaggio fino alla curva coloristica del timbro che si flette nel tempo o dell'Egmont, tutto contro Goethe e in favore di Beethoven (del quale Goethe avea rifiutato le musiche di scena), che Deleuze definisce "Una sfida e una vittoria del modale". Sinfonismo di sala forse anticipato nelle ataviche lotte con i poemi: la Lectura Dantis dalla Torre degli Asinelli nella Bologna 'sognata' in merli medievali, "come profferta da ser Boccaccio settecento anni fa", o nei rimbombi orfici di campana, o in 'quattro diversi modi di morire in versi', dove la voce si fa ascolto e dispare in estasi mariane o in orgasmi berniniani di sante Terese o di beate Ludoviche Albertoni. In mezzo sta il canto, l'attonimento celestiale di una fine della rappresentazione e del campo sgombro - ormai camposanto - dei propri doppi moltiplicati... Von Sacher Masoch, Sade, Nijinskij, Leopardi, Laforgue... Sottoporre la lingua e tutti gli elementi interni della lingua: fonologici, sintattici, semantici, gestuali, coreutici, al lavorìo della variazione continua - già lavorìo barocco in fughe di soggetti e contro-soggetti -. Non padroneggiare mai il dominio. Naufragare nella variazione perpetua. Ottenere il balbettìo incidendo solchi che trascinano il linguaggio fuori da un sistema di dominanti.
La musica diventerà quindi luce, linea di variazione: "... aria, terra, sole, colori, luci e suoni", come dice Deleuze. Scivolamenti degli oggetti/affetti/vestiti/fiori che ingombrano la scena in Riccardo III e in S.A.D.E....costumi che cadono, oggetti, mobilio ingombrante.
Lo spazio della prossemica si nega in ostacolo, il gesto della cinesica si annichilisce in tratto, la visione è l'oscurità: la luce viene usata o 'sciupata' come musicalità. Al di là del testo, del pensabile, del senso. Il buio è l'eccedenza della luce come l'assordamento è l'eccesso del suono. In un caso e nell'altro si s-dà e si appanna ogni contrappunto: il pathos artiglia i misteri fonici ed eidetici e li sbarazza in giro. Tutto è suono: gli oggetti, i corpi, le idiofonìe dell'architettura, della quinta. Le differenze in musica splendono come differenze deleuziane, come mere finzioni di David Hume: taglî di lingua, di trama, di mondi...
Il klossowskiano 'principe delle modificazioni', affogato nell'oblio-partitura della musica, trova la sua nemesi nel play-back, affacciatasi come disciplina assoluta e ascetica della 'sparizione', non certo come mezzo 'facile', accomodante. Il play-back è un aiòn destinale che fa circolare un pneuma irrespirabile, al modo stesso che il non-sincrono tra suoni e immagini nei film aprono epigrafi funerarie, iati di ostranenie. La voce viene sbrecciata in costolature di ululati, di barriti, di cinguettìi... Musica che si fa scarto, malattia: lo stato di grazia come il vizio amletico, come il molecolare, chimico disgregarsi dell'attore, come un decadentismo di epici disagi musici: "Che Des Esseintes non possa dirigere un'orchestra di liquori non è forse più importante di un'esecuzione riuscita di Von Karajan?"
Lo scandalo, l'inciampo, la provocazione, l'ostacolo sono il bagaglio pesante e contraddittorio della nascita del suono, come della nascita del soma: delitto escrementizio di femmina-regina, Giocasta accampata nell'Edipo dei nostri dubbi, dei nostri enigmi sul musicale.
E a Edipo, a Des Esseintes, al servo-padrone del S.A.D.E., fa eco Don Giovanni nell'inferno musicale, liberato per sempre da Da Ponte, e restituito alla rosea cifra del femminile come mancanza. Proprio il dongiovannismo narcisistico sporcato e riscattato in Leporello. Kierkegaard... L'ascoltarsi anche dell'erotismo, del desiderio che ci abbandona, del mortificare il presente in corpi-di-femmina o in note-di-musica. Le note-bambine mozartiane (certo: l'amatissimo Mozart, contro le cui mise en scène Carmelo si scaglia: "Non mi riesce di ascoltare Mozart senza il castigo visivo d'un salotto", come del resto per Verdi: "Il fasto cafone o la frugalità miliardaria delle messinscena verdiane") che sono l'idioma con cui parlano gli angeli tra di loro. Emblema o ninnolo di quanto è arte, valendo per quanto 'manca', per quanto è fuori dall'opera ed è 'capolavoro', è miracolo mariano del vedersi specchiati stecchiti nella Madonna che si è. "Sono apparso alla Madonna".
E al medesimo modo Carmelo Bene affranca anche i suoi autori amati, dispensandoli d'esser in opera, svelando a loro dispetto l'origine non-originale che li precede. Ne è la voce che anticipa il loro testo, che ne benedisce il manque à être. Per Bene il genio di Verdi, già bollato in Credito italiano V.E.R.D.I., in tempi non di claque-centenario, quello di Mejercho'ld, di Cajkovskij, di Beethoven, di Marlowe, di Lautréamont, di Schumann, di Velazsquez si alternano nella risonaza lirica della lettura-scrittura di scena, nell'oggettivarsi attoriale in fonemi.
Solo in exitu Carmelo si concede alla poesia, alla composizione: eccome se affrancando se stesso nell'ultimo meta-baudelairiano 'l mal de' fiori! "Prima di questo 'L mal de' fiori non mi ero mai imbattuto in una nostalgia delle cose che non furono mai in nessuna produzione artistica (letteratura, poesia, musica)". In esso, del musicale poetico, para-dannunziano o pompieristico, si conserva improvvisamente il diffrangersi tipografico... i tritatutto graffitistici di Cummings, i calligrammes di Apollinaire, la scrittura-pittura di Ezra Pound, ri-adattati in tracciati scritturali dove la phoné si è mutata in graphein. Più che un comporre, che un imbastire un testo, è un ritirarsi, un dekomponieren di sentenze in caduta.
"Non si può che confermarsi 'stranieri nella propria lingua'... Il plurilinguismo (crogiuolo di idioletti, arcaismi, neologismi di che trabocca il poema) è il contrario d'una accademia di scuola-interpreti. È 'nomadismo': divagazione, digressione, chiosa, plurivalenza, etc. Il testo intentato è (deve essere) smentito, travolto dall'atto, cioè de-pensato. L'oggettivarsi è l'eccedenza del progetto, al modo che la musica è l'ascolto stesso. Poesia è l'immediato nella ruminazione orale d'uno scritto già estraneo a noi dicenti. Scritto in Voce. Voce come ri-animazione (rigor-mortis) del morto orale che è lo scritto... Questo 'L mal de' fiori è un ventaglio di differenze".
In parallelo a questo nulla in iscritto va l'ultimo nulla a teatro. Poco più in là c'è solo il tempo di dissipare anche questa "stagione di nostra vita meteora", che ci si accorge immediatamente di quanto solo l'impossibile sia frequentabile, a teatro come nella vita. È l'avvento della macchina sepolta sotto la piramide dei microfoni, del play back totale. Quell'ultimo anticipo del teatrico che per Carmelo Bene è il play-back in Achille: un funerale dell'avvenire...
Il nothing dittatoriale folgora come un nume la sua 'apparizione': non c'è narratore in questo spettacolo, non c'è soggetto, non c'è storia. Un'Achilleide, rivisitata molte volte e in molte occasioni, fa tabula rasa negli eterniritorni della necrofilia. Non c'è un linguaggio, non c'è rappresentazione, non c'è un 'io'... siamo già all'ultimissimo Invulnerabilità d Achille (impossibile suite tra Ilio e Sciro), siamo già a Sciro, l'isola di Licomede, dove la premura materna di Teti ricovera Achille (ricercato da Giove) truccato da bambina, che gioca con Deidamia e la mette incinta a 10 o 11 anni. Sciro è la felicità infantile, il passato mai presente a se stesso, il tempo dell'impossibile'. Siamo già alla necroflia sul corpo di Pentesilea, posseduta in un flash da morta, mentre Achille sente il brulicare dei vermi che abitano la sua stessa carne. Auto-necrografia... Siamo già ai rantoli della 'precocità della morte': Achille vuol dire 'chi giovane si muore'. Egli è il mito dei miti. I suoi doppi sono infiniti. È uno che "Se avesse potuto esistere avrebbe voluto vivere... Invulnerabile ma vulnerabilissimo".
La musica sente già i vermi che si agitano nella carne quando questa è ancora viva. E il testamento è di fatto intestimoniable, è già fuori dal teatro, compreso quello stesso di Bene. In scena non c'è nulla. "C'è solo il miracolo che procura miraggi". Achille non si occupa più di teatro. La grande arte è nella differenza, se ne infischia dell'arte, si eccede. È lo s-concerto.
La phoné greca, come protesi-altra del corpo-voce attoriale, vicina alla deità, nell'irrompere in altri candidi firmamenti, in semicerchi scenici sofoclei o in settecentesche bomboniere stuccate a oro, uccide comunque l'attore da vivo. Si rimane trascolorati nella scenografia, come in un'ideale reggia di Metastasio o nella 'battaglia della foresta' macbethiana; è il non-esserci e come tale tremola in trousse, in vitro, in cipria: soffia dappertutto come un polline stregato, un'insinuazione ensorcellé di musica; è il monitor, le casse, la batteria degli spot elettrici, i mixer...
La béance offusca in nerofumo questo melodiare attardato di spettri vagabondi, arrotola in pieghe i margini delle forme. In musica come in cinema l'asincronismo smarrito in cerimonia di tēchne perfora il soggetto fino a polarizzarlo in oggetto.
La musica è oggetto per un 'altrove', non si è nient'altro che musica: pulsazione costellata di colpi singolari, ruggito tenorile che ha in serbo la concezione della vita come dépense e il senso dell'orchestra "a fossa vuota". Regressione nell'inorganico, geologia melodica come purezza, infanzia d'incantesimo senza ragione, nello stupore delle variazioni della terra salentina: infinite visioni smaltate tra il mare e il fogliame degli alberi di fico, a picco in controluce accecante... ancora un ritmo tra la luce e l'ombra...
... il nulla in sei ottavi.
Riccardo Vaia (da www.orfeonellarete.it)