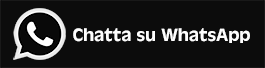Arancia balcanica
A noi, per farci scoprire che esistevano i Balcani c'è voluta una guerra. A loro, per farsi una ragione della follia irrazionale che quella guerra l'ha attraversata e nutrita c'è voluta l'arte. Tutta la loro arte. La catarsi eterna e faticosa del raccontare per capire, del ridere per buttar fuori, per far diventare storia il dolore.
Così sono venuti i film di Emir Kusturica, la generazione minata di Underground, di Prima della pioggia, di Gatto nero gatto bianco e No man's land. Un cinema tragico e grottesco che abbiamo avuto tanto bisogno noi di vederlo quanto loro di farlo.
E poi la musica: le polke epilettiche di Goran Bregovi?c, con quei bombardini che muggiscono, il baccanale chiassoso dei rullanti, i rallentando improvvisi, le svisate a cinque quarti che s'allontanano a balzelloni come uno zoppo in fuga. Tutto già stato moda, tutto ormai rientrato al posto fisso del nostro immaginario d'europei.
Naturale che il teatro venga dopo. Più difficile delle immagini, meno universale dei suoni, ogni volta da tradurre e delibare con fatica. Per questo Bure Baruta, anche se non è ultimo, arriva solo stasera su una scena italiana.
Le date sono importanti. Dejan Dukovski non è un epigono furbacchione. Nato a Skopje nel 1969, Bure Baruta lo scrive a soli ventiquattro anni quando la Jugoslavia è un cumulo di macerie ancora fumanti, una ventraia di trincee, un labirinto di scheletri dove tutti sono nemici di tutti ma dove dalle crepe del sottosuolo già lampeggiano i nuovi inferni del Kosovo.
Bure Baruta (La polveriera) debutta nel 1993 al Teatro Nazionale di Skopje. È il primo spettacolo macedone a salire il grande palco del Teatar Drama e il Festival Bitef di Belgrado, a due passi da Milosevi?c che abbozza. Nel 1996 è ospite alla Biennale di Berlino. Va in scena in Olanda, Svezia, Slovenia, Polonia, Grecia, Germania, Austria, Bulgaria, Inghilterra, Finlandia e Francia. Per farsi conoscere da noi deve diventare cinema: sgradevole e disperato, il film di Goran Paskalijevi?c con lo stesso titolo e i dialoghi di Dukovski vince nel 1999 a Venezia il premio della critica, salutato come un paradigma del nuovo black humour balcanico.
In realtà La polveriera non è uno spettacolo "sulla" guerra. I suoi alcolisti anonimi, i clochard saturnini, gli infagottati viaggiatori notturni da e per nessun posto sono un popolo delle tenebre dove il bene e il male sono sfumati dallo squallore radente delle lampadine. Qui nessuno è interamente buono o cattivo. Non esistono vincitori e vinti, colpevoli e innocenti perché non esistono comportamenti etici assoluti. È un'umanità astiosa e percossa che non racconta il disastro morale d'ogni dopoguerra, ma l'impasto fetido di torti e ragioni che è lievito velenoso di tutte le guerre imminenti. Una sospensione del giudizio morale che Dukovski sa trasformare in una macchina da supplizio drammaturgico.
Undici scene. In ognuna un morto per futili motivi, per raptus insensati. Delitti non-esemplari dove per lo spettatore è ogni volta più difficile schierarsi, distinguere tra vittima e carnefice. Il meccanismo è il rovescio macabro del Girotondo di Arthur Schnitzler. Là era il giro di valzer d'ufficiali e cocotte sull'orlo del Grande Massacro. Qui è la danza sbilenca di chi aspetta un bus o una vodka e trova la morte, la canzone ritmata dal suono di vetro e ossa d'una bottiglia che si spezza contro un cranio. Dimitrije e Angel, Angel e Sveto, Sveto e Simon. Qua, nella scena successiva, compare chi dei due sopravvive.
Una volta in un'intervista Dukovski ha dichiarato che la sua in realtà è una pièce sull'amore, un amore che deflagra nel momento in cui i personaggi prendono coscienza d'appartenere allo stesso sistema-tritatutto. Ma è un amore che, per non commuoversi, va esorcizzato con l'umorismo più nero, con l'efferata ultraviolenza di un'"arancia balcanica".
La regia di Davide Livermore scava nelle pieghe rancorose del testo senza bisogno di enfatizzare né di lenire nulla. Le persone si muovono su un piano inclinato metafora d'un mondo instabile e obliquo che ne distorce il valore morale. La pantomima in cui la suora, l'imam, il pope, il rabbino e Clinton s'inseguono in una ridda sodomita è tanto il Trionfo della morte di Bruegel quanto un siparietto di Paolo Poli. E la donna delle pulizie che lava via il sangue con secchio e spazzolone sarà anche un atto di cinismo brechtiano, ma quantomeno non lo è più dell'indifferenza apparente con cui le musichette da nozze o cantastorie del Sandy Lopici´c Grupa esplodono crudeli fra un delitto e l'altro. Dalla Serbia alla Grecia, dalla Bulgaria all'Albania, dalla Bosnia alla Turchia: per riconciliare matrici culturali comuni e frullarle in un pacifico, incasinato e fascinevole Balkan Blues ha fatto più Sandy Lopici´c con la sua Band che tutta l'Onu messa insieme.
A sorpresa, fra le impennate sentimentali del complesso folk, s'infrattano qua e là pagine sublimi del melodramma serio europeo. La sinfonia del Farnace e un'aria con oboe obbligato del Tito Manlio di Vivaldi, l'aria di Septimius della Theodora di Haendel arrangiate da Andrea Chenna per gli strumenti balcanici. In quei suoni striduli di violini, fisarmoniche, trombe e bassi, in quelle raffiche (campionate) di kalashnikov, le pose plastiche degli eroi barocchi si riscaldano e si sciolgono a dirci che la vita è sempre un mercimonio insolubile di alto e basso, di tragedia e grottesco. E che i Balcani possono essere dovunque, e non serve un'altra guerra a ricordarcelo.
Nicola Gallino (da www.sistemamusica.it)